Male vite tra macerie e frontiere
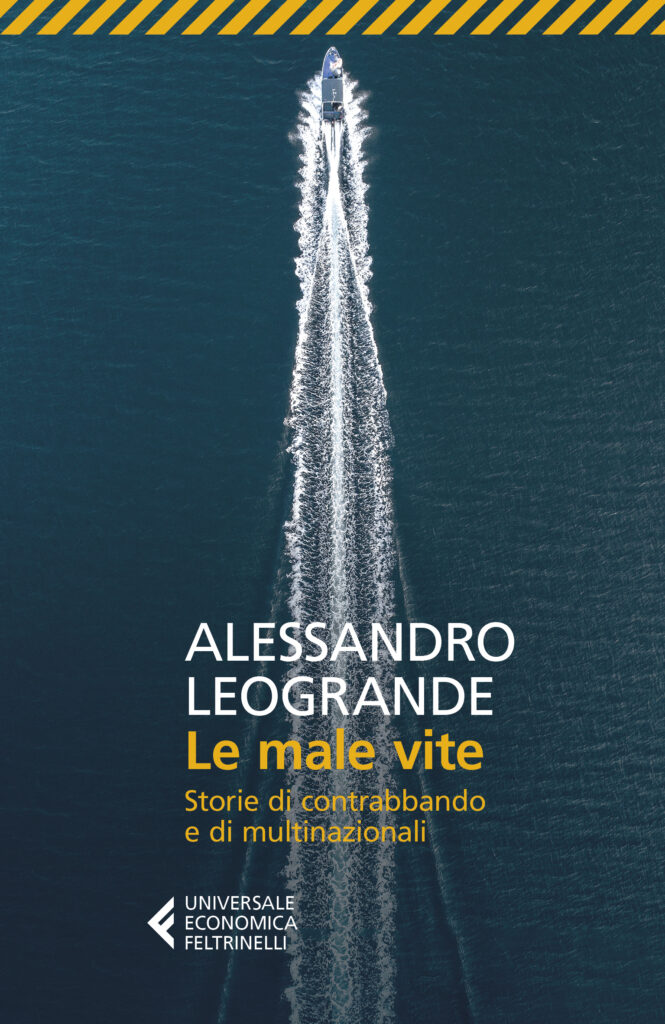 31 Marzo 2021
31 Marzo 2021
Pubblichiamo la prefazione di Gianfranco Bettin a Le male vite. Storie di contrabbando e di multinazionali di Alessandro Leogrande, in uscita per Feltrinelli (collana UE), per gentile concessione dell’editore. “I libri di Alessandro sono qualcosa di più che delle inchieste, sono buona letteratura,” ha scritto Goffredo Fofi introducendo il volume che Leogrande ha dedicato a […]