Contro l’università. Per una sociologia come ricerca
di Stefano Laffi
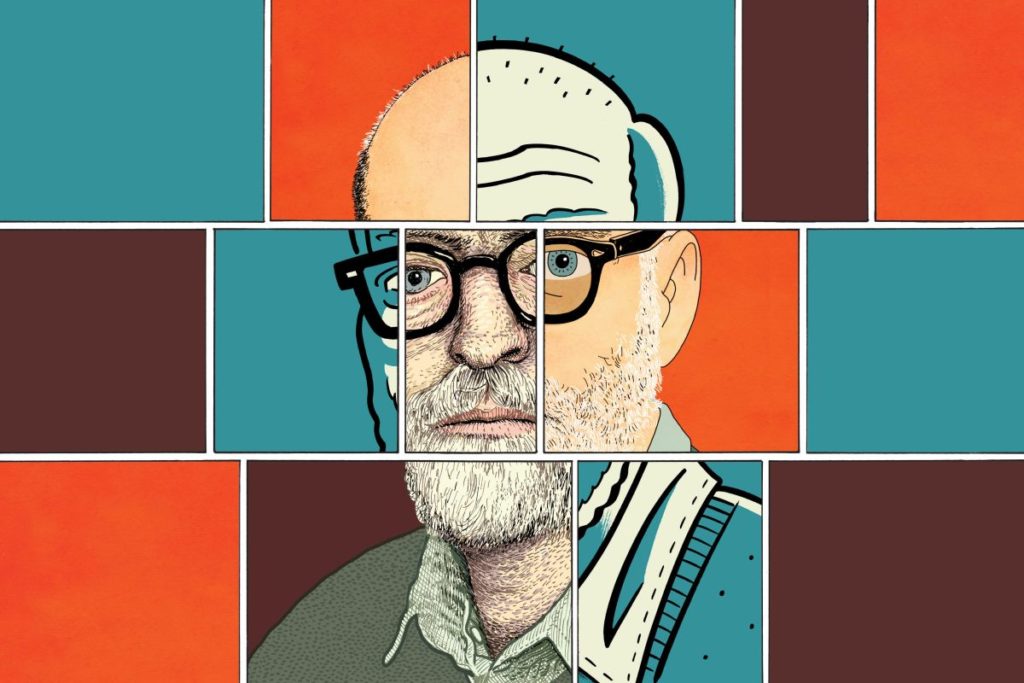
Questo intervento, uscito sul n. 44 de “Gli asini”, fa seguito a quello di Vando Borghi pubblicato nel n. 41: acquista il numero o abbonati ora per sostenere la nostra rivista.
Sono arrivato alla sociologia dall’economia, che trovai una disciplina antibiologica, per come tratta la natura e l’uomo – risorse da sfruttare, costi di bonifica e di scioperi da contenere – e in parte fasulla, perché fatta nella dottrina universitaria di modelli che funzionano su ipotesi irrealistiche, nascoste dietro l’incessante uso di diagrammi. Nella sociologia sentivo e sento quel giusto debito alla complessità del mondo, senza sconti cioè spesso senza sintesi, un umanesimo di cui l’economia è priva, una dialettica aperta e meno schierata aprioristicamente per scuole, come succede alla psicologia. Alla Bocconi, dove studiavo, c’era un solo esame di sociologia, di nessun peso, e intuii che quella doveva essere la spina nel fianco di una disciplina come l’economia altrimenti potente, e supponente, a cui devo però la conoscenza della matematica e della statistica e la chiave di accesso alla prospettiva dominante sul mondo: sotto la lente del profitto tutto appare diverso – un bambino, un albero, una malattia, un libro – quando te ne accorgi ti spaventi ma capisci molte cose.
In breve, mi sono laureato in economia politica e poi dottorato in sociologia generale negli anni Novanta, compiendo un salto disciplinare che allora era fantascienza e oggi è sacrosanto ai tempi del 3+2. All’esame orale del dottorato mi chiesero che ci facessi lì, fuori posto, facendomi sentire ospite sgradito. Avendo affidato ai romanzi, alla poesia e al cinema il mio dialogo interiore, la mia formazione sentimentale, ho sempre chiesto alle categorie sociologiche di darmi invece una visione del mondo, una comprensione della contemporaneità, praticando alcune incursioni fuori scaffale laddove trovavo suggestioni interessanti, come il Disagio della civiltà di Freud o Miti d’oggi di Barthes, Lettere luterane di Pasolini o La grande trasformazione di Polanyi, i libri di Ivan Illich, Colin Ward o Christopher Lasch, insomma quei testi scoperti da autodidatta e fondamentali per capire il presente, ignorati in università perché scritti fuori dai canoni accademici.
A distanza di vent’anni posso dire di aver praticato incessantemente la ricerca sociale fuori dall’università (in centri di ricerca privati, poi in una cooperativa sociale fondata con amici) ma di aver letto pochissimo la sociologia, quasi fosse più da scrivere e riscrivere, alla luce di fenomeni in continua evoluzione. Dei best seller della disciplina – Baumann, Giddens, Sennett, Beck, eccetera – ho avvertito a un certo punto la ripetitività dei più, come succede a quegli attori prigionieri in un ruolo di successo, e solo Sennett mi ha suscitato continua curiosità anche a fronte di esiti discontinui, per una scrittura erudita ma non accademica, per i suoi continui sconfinamenti disciplinari e la capacità di mettere la propria esperienza biografica a servizio dell’analisi, per la tensione di un vero programma di ricerca su alcune grandi questioni del nostro tempo. Altri libri preziosi sono stati scritti in questi anni, più di ricerca – penso a La miseria del mondo curata da Bourdieu o Una paga da fame di Barbara Ehrenreich – ma non ho mai visto la sociologia in testa alle classifiche. Intanto, entro i nostri confini, forse solo i libri di Gallino e gli articoli sui quotidiani di Diamanti e De Rita riuscivano a regalare alla sociologia il ruolo di chiave di lettura del presente per il grande pubblico, ma va detto che nel frattempo sui quotidiani il danno era stato fatto, il “Corriere della Sera” aveva visto succedere Alberoni a Pasolini nella rubrica del lunedì in prima pagina, e infine ora ad Aldo Grasso, la critica sociale era divenuta sociologia dell’amore o buon senso moraleggiante, per chiudere oggi in gossip e tirata d’orecchie alle celebrities.
Culture, generi, migrazioni, disuguaglianze, conflitti..: se si scorre l’indice di un manuale di sociologia ci sono i grandi temi di oggi, Vando Borghi ha ragione nel recente intervento su questa rivista quando ne vede intatto il potenziale disciplinare, come a dire che se la sociologia facesse il suo mestiere dovrebbe risultare preziosa nel decodificare il presente. Ma allora perché, solo per fare un esempio, tocca a Roberto Saviano smentire Matteo Salvini e la Lega sulla realtà dei fenomeni migratori – o alla voce.info per chi la frequenta – perché non c’è una lettera dei seicento professori universitari come quella scritta contro il decadimento delle competenze di scrittura degli studenti ma questa volta stesa contro il decadimento dell’analisi e della verità nel discorso pubblico della classe politica?
Le ragioni della crisi disciplinare della sociologia vista ai margini del suo tempio – l’università, guardata da professore a contratto occasionale – sono evidenti, ben note, credo comuni a molte facoltà. Il regno è stato diviso in mille potentati per regalare a ogni città il lustro di una facoltà e a ogni professore la sua cattedra, per cui oggi esiste la sociologia di ogni cosa, col continuo rinnovo dei nomi degli insegnamenti per ragioni di marketing, anche a costo di avere due studenti per ogni insegnamento. Ognuno difende il suo fortino, in una continua guerra di posizione, così che molto del lavoro rimane sotto massa critica e impermeabile all’interdisciplinarietà. Il meccanismo dei crediti corrompe lo studio perché sposta sul calcolo insegnamento e studio – mi è stato detto “non suggerire letture perché il tuo corso non ha crediti abbastanza per avere una bibliografia, così favoriresti qualcuno”; quello delle pubblicazioni porta a esiti perversi – molto meglio non scrivere un libro ma spacchettarlo in articoli per riviste specialistiche, così da accumulare punti. La scrittura accademica appare sempre più autoreferenziale e inutile, l’iter previsto per le carriere universitarie alimenta rapporti umani avvelenati e di facciata, la burocrazia interna distrae dalla vocazione di luogo di ricerca. Il risultato è che una disciplina chiamata a interpretare il presente è consumata in specialismi irrilevanti, in interessi particolari e in regolamenti di conto interni alle facoltà, che l’università è uno dei luoghi dove più si pratica ciò che la sociologia stigmatizza ovvero l’ingiustizia sociale (lavoro gratuito, disparità di reddito a parità di prestazione, difesa dei privilegi e rendite di posizione, gerontocrazia, opportunismi e clientelismi…) con rarissimi casi di autocritica, coming out, dissenso o disobbedienza civile. Il paradosso è una colossale dissipazione del tempo di studio di migliaia di studenti universitari in rivoli di temi, fenomeni, questioni che scivolano sul presente: sono certo che esistano – o ce ne sia il potenziale – decine di tesi di dottorato capaci di regalarci intuizioni e spiegazioni preziose su porzioni del mondo, ma i meccanismi dell’università le tengano in ostaggio, chiuse a chiave. E va aggiunto che questo stile di insegnamento e di studio ha anche neutralizzato l’insorgenza di qualunque passione civile, a furia di controllare la letteratura di riferimento e in ossequio a un malinteso principio di scientificità non c’è mai a lezione una presa di posizione, il coraggio di una visione e la legittimazione dell’immaginazione, la forza di un progetto di cambiamento, l’idea di una mobilitazione, una chiamata all’impegno pubblico di nessuno, studenti o professori.
Una sociologia così pavida non mi interessa, per questo ho fatto ricerca, e l’ho fatta fuori dall’università, con incerte fortune. Negli anni mi ha fatto scandalo non tanto il declino dell’università che credo comune ad altre facoltà, ma il fatto di non darsi il compito del cambiamento, cioè l’illusione di credere che il capolinea della disciplina fosse la lezione in aula o l’articolo accademico o divulgativo, non l’intervento sul campo. Sono figlio della sociologia della Scuola di Chicago, quella che professava negli anni Venti e Trenta l’immersione nei contesti di ricerca, e non riesco più a capire come si possa scontare a una disciplina come la sociologia il debito con l’intervento sulla realtà, con le persone che la vivono. Anche perché c’è il rischio che la teoria non regga quella prova: se racconti che le differenze sono una ricchezza e la multicultura è il regalo del nostro tempo, quando ti presenti in un condominio metropolitano dove convivono nazionalità e generazioni diverse ti sbranano, rischi di non capire che quei discorsi funzionano solo se prima risolvi la gestione della raccolta differenziata per chi non la conosce, se trovi un sistema di rientro dei debiti delle spese condominiali non pagate, se crei un’economia virtuosa di scambio fra le risorse presenti nelle famiglie, se spegni il senso di insicurezza organizzando ritualità di conoscenza reciproca e poi di festa, eccetera. Insomma, se la sociologia non si sottopone a queste prove di realtà non è più credibile, perché i repertori di esperienza individuale delle persone dicono altro, e sulla propria pelle: non puoi sovrascrivere l’ideologia dell’intercultura a chi ha paura del vicino, devi partire da quella paura, riconoscerla.
Fare ricerca e intervento richiede tempo, sacrificio personale in orari e situazioni che dipendono dai contesti, restituisce risultati provvisori, non consente di scrivere, tutti elementi che la rendono incompatibile con la pratica universitaria. Ma questo modo di agire la sociologia ha un grosso limite, tipico dei mestieri su commissione, quello di “subire l’agenda”. Quando ho iniziato a fare ricerca erano gli enti pubblici a commissionare i temi, il rischio era quello di dipendere dalle sensibilità della giunta di turno, il vantaggio quello di lavorare a fianco di chi governa i territori, incidendo sulle politiche. Oggi questa committenza non esiste più, è arrivata la crisi e ha vinto la comunicazione, cioè nel tempo la domanda di ricerca e formazione si è assottigliata nella richiesta di partecipazione a convegni e seminari, la deriva è stata quella della parata disciplinare dove il sociologo sta accanto allo psicologo, all’urbanista, eccetera. E nel discorso-spettacolo disciplinare la sociologia è perdente, vince il criminologo o lo psicologo, perché quei saperi si prestano meglio all’evocazione emotiva richiesta dall’audience.
Oggi sono le fondazioni bancarie e private in generale a offrire le risorse per sopravvivere alla ricerca sociale, insieme ai programmi europei. Questo ha liberato la sociologia che ho praticato dal ciclo politico locale, ma certo ha spostato l’agenda dei temi, a volte dei metodi e delle ideologie, lontano da me e dal territorio. Spesso in questi anni ci siamo chiesti a Codici, dove lavoro, se ci occupiamo dei temi di cui è importante occuparsi, e la risposta è solo in parte positiva. Mi piacerebbe una sociologia al servizio dei processi di autodeterminazione dei migranti o dei bambini, per fare un esempio di questioni proposte e discusse in questa rivista, ma nessuno ti paga per questo, le parole d’ordine sono integrazione, sicurezza, coesione.
Non mi viene da difendere la disciplina, anzi, più volte mi sono detto che lavoro per la morte del mio mestiere, cioè la sua dissoluzione in conoscenza diffusa: si può insegnare a far ricerca ai bambini, a svolgere un’intervista dopo un paio d’ore di istruzioni e prove, a tradurre l’esperienza quotidiana di chiunque in apprendimenti sociologici, a fare esercizi di spostamento del punto di vista in una mattinata al liceo, a trovare la miglior sociologia del presente nei romanzi di Ballard, i più acuti esercizi metodologici in quelli di Perec. Appena ci si pone la questione del presente e si accetta di non avere le risposte ma doverle cercare, si è già dentro la ricerca sociale.