Lo Stato è tornato e non se ne andrà tanto presto
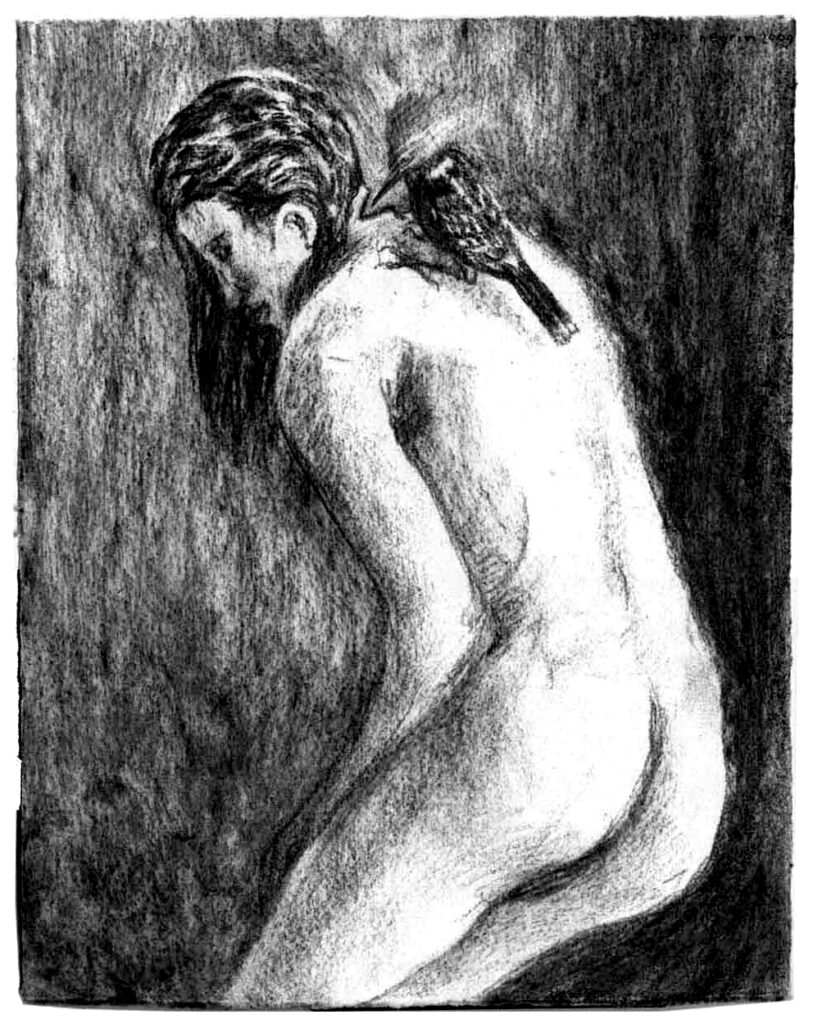
È tornato lo Stato nella sanità, nell’economia, nella società. La pandemia che ha duramente colpito l’Italia – provocando un’emergenza sanitaria impensabile, il rallentamento fino al blocco del sistema scolastico, il congelamento delle attività produttive e un netto allargamento della forbice tra chi sta meglio e chi sta peggio – ha reso necessario un intervento pubblico di dimensioni straordinarie, “come in tempo di guerra” si è detto e scritto. Sono stati spesi miliardi di euro, nessuno (nemmeno i più rigorosi custodi dei vincoli europei di bilancio) ha potuto eccepire davanti allo sfondamento del tetto del debito e del deficit per fronteggiare l’emergenza in cui è piombato il Paese, assieme a tutto il mondo.
In quest’anno difficile, che forse ci porta fuori dalla pandemia, in questo 2021 in cui ricordiamo la nascita della nostra amata e malmessa Repubblica “antifascista”, “democratica”, “fondata sul lavoro”, torna prepotente e indispensabile la presenza della mano pubblica, riparte un vivace dibattito politico attorno al principio dello Stato in economia e del suo ruolo storico nello sviluppo del Paese. Un dibattito che si alimenta delle nomine dei vertici delle imprese pubbliche e delle proposte per l’utilizzo dei fondi europei, in un contesto politico dove, in presenza di partiti inetti e impresentabili, il leader indiscusso è Mario Draghi, ex direttore generale del Tesoro, ex banchiere privato, ex Governatore della Banca d’Italia, ex presidente della Banca centrale europea.
Oggi c’è un generale consenso sul giudizio per cui lo Stato ha svolto un ruolo decisivo per contrastare gli effetti devastanti del Covid-19: ha sostenuto imprese e lavoratori, ha fronteggiato l’emergenza sanitaria e ha investito sui vaccini, facendosi carico ovviamente dell’enorme crescita del debito pubblico. Adesso, però, che il coronavirus s’indebolisce grazie alla campagna vaccinale e s’immagina un ritorno alla normalità, ammesso che si possa tornare alla realtà di due anni fa, aumenta l’allarme di chi teme uno Stato invadente, accentratore, ipertrofico, penalizzante per il mercato o le imprese private, mentre altri sostengono che lo Stato avrà ancora un ruolo determinante in futuro.
Non è un confronto solo italiano, in tutto il mondo si discute sul ruolo e la funzione dell’intervento pubblico. Si richiamano Keynes e Beveridge, si discute della Grande Depressione e del New Deal, si definiscono piani straordinari di investimento di valore superiore al Piano Marshall. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta affrontando la crisi post-Covid a colpi di trilioni di dollari pubblici. La Francia rafforza la presenza pubblica nei settori strategici e non è casuale che, pur in mezzo alla pandemia, il governo di Parigi, ad esempio, abbia mantenuto la presenza strategica come azionista di Stellantis, la società automobilistica nata dalla fusione tra Fca e Psa. L’Europa, per la prima volta, ricorre a un debito comune per finanziare una stagione di rinascita. I fondi pubblici stanziati dai governi sono stati determinanti per finanziare la ricerca dei vaccini, anche se i campioni di Big Pharma si oppongono alla richiesta della Casa Bianca e pure di Draghi di togliere i brevetti per favorire la diffusione gratuita dei vaccini. Solo la poverissima Cuba ha investito e prodotto 100 milioni di dosi, gratuite.
La questione è di grande importanza perché la pandemia ha richiamato in servizio lo Stato in un Paese come il nostro dove moltissimi, soprattutto i giornali dei padroni (la Repubblica, la Stampa) o dei padroncini (il Corriere della Sera), si dichiarano liberisti e sostengono il mercato e la concorrenza, salvo implorare la protezione, l’aiuto pubblico ai primi rovesci. L’emergenza sanitaria, umanitaria, sociale ed economica ha sollecitato il mondo politico e accademico a ripensare il modello economico (gli ultimi libri di Thomas Piketty e di Mariana Mazzucato sono degli esempi), le relazioni sociali, le politiche di produzione e di redistribuzione del reddito. “Il ritorno dello Stato”, discusso al Festival dell’Economia di Trento di quest’anno, è così forte da rompere barriere ideologiche, radicate convinzioni politiche e anche rilevanti interessi finanziari. Nel mondo emergono novità impensabili fino a poco tempo fa. Non sappiamo dove porteranno, ma la realtà di questi mesi è chiara.
Oltre ai già citati maxi interventi pubblici della Casa Bianca, c’è di più. Il premier britannico, il conservatore Boris Johnson, che attribuiva a “capitalismo e avidità” i successi del suo Paese contro il Covid, ha annunciato la nazionalizzazione delle ferrovie di Sua Maestà la cui privatizzazione era stata un vanto della signora Margaret Thatcher. La motivazione è semplice: i treni gestiti dai privati non funzionano e sono troppo cari. Gli inglesi, quelli che hanno votato per la Brexit, tornano indietro, almeno in questo caso. E viene alla mente un testo di Ian McEwan degli anni Novanta molto critico sulle politiche dei conservatori: “Le privatizzazioni selvagge hanno cambiato la nostra vita e ci hanno scippato le nostre tradizioni. È un paradosso, ma la rivoluzione thatcheriana ha distrutto i valori più profondi dell’elettorato conservatore”. Un grande pensatore inglese, anarchico, come Colin Ward scrisse parole di fuoco che prevedevano il disastro sociale che sarebbe seguito ovunque: “Il trionfo dei valori del mercato non solo in Inghilterra, ma in tutto il mondo, riporta la civiltà umana indietro di molte generazioni”.
In Italia stiamo assistendo a novità importanti in merito all’intervento pubblico, che alcuni giudicano denso di incognite se non addirittura pericoloso. L’ex premier e commissario Ue Mario Monti, ad esempio, teme il ritorno dello “Stato-mamma” che si prende cura di tutto e di tutti. La Confindustria non rifiuta gli aiuti e i sostegni decisi dal governo o i prestiti garantiti dallo Stato (la Fiat di John Elkann, ad esempio, ha incassato un finanziamento di 6 miliardi di euro erogato da Intesa Sanpaolo con garanzia pubblica, questo non ha evitato di mettere in cassa integrazione migliaia di operai), ma vorrebbe assicurazioni sul veloce ripiegamento della presenza statale. In realtà si può affermare oggi, fatti alla mano, che lo Stato non si ritirerà tanto presto e, anzi, è destinato ad allargare la sua presenza proprio per la malagestione e il fallimento dei privati nella conduzione di imprese già privatizzate. Tornerà pubblica, se vivrà ancora, l’ex Ilva di Taranto e lo Stato sta rimettendo in pista quel che resta di Alitalia. Tornano anche le Autostrade, un esito quasi obbligato dopo il crollo del Ponte Morandi, i 43 morti, e le indecenti telefonate tra i manager dei Benetton intercettate nel corso dell’inchiesta giudiziaria. Non c’è bisogno di altro per procedere alla nazionalizzazione di Autostrade. Dispiace solo che i Benetton abbiano recuperato l’intero investimento realizzato al momento della privatizzazione e che abbiamo incassato milioni di dividendi, frutto della rendita sicura garantita dalle tariffe.
Il fronte delle aziende pubbliche merita qualche attenzione. Mario Draghi, il regista delle privatizzazioni negli anni Novanta quand’era direttore generale del Tesoro, ha avviato la tornata di nomine delle imprese di Stato con un metodo semplice: scelgo i “migliori”, non ascolto i partiti. Qualche esempio. Alla Cassa Depositi Prestiti è arrivato come amministratore delegato Dario Scannapieco, che lascia la vicepresidenza della Bei; alle Ferrovie la scelta è caduta su Luigi Ferraris, già all’Enel, Poste e Terna, come amministratore delegato, presidente Nicoletta Giadrossi, un curriculum internazionale. Carlo Fuortes, manager di teatro, è chiamato a guidare la Rai. Come leggere queste mosse di Draghi e del ministro dell’Economia, il tecnico Daniele Franco? Una strategia d’innovazione e di valorizzazione delle imprese pubbliche non al fine di privatizzarle, ma con l’obiettivo di guidare la rinascita del Paese utilizzando al meglio i fondi europei destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. È utile sottolineare come in questa estate 2021 in cui le imprese private (Gkn, Gianetti Ruote, Whirpool) sono tornate liberamente a licenziare perché il capitale non guarda in faccia a nessuna emergenza sociale, la tutela pubblica del lavoro e del reddito rappresenta ancora un valore. La “funzione sociale dell’impresa” è di lavorare per la crescita, di creare buona occupazione, di avere bilanci in ordine, di garantire rapporti trasparenti e proficui con le comunità in cui opera. Se questi principi valgono, in linea teorica, per i privati, devono contare molto di più per le imprese pubbliche che, pur aperte al mercato, hanno responsabilità economiche e sociali rilevanti.
La Cassa Depositi Prestiti è il motore di questo processo, una cassaforte che custodisce 275 miliardi di risparmi postali. Le Ferrovie hanno già 30 miliardi da investire. I fondi europei sono determinanti e bisognerà ricordare ai sovranisti e agli xenofobi leghisti e compagnia che se l’Italia è ancora in piedi è perché nell’ultimo anno e mezzo la terribile Bce, violando le regole che noi italiani abbiano sottoscritto, ha comprato una quantità enorme di titoli del nostro debito pubblico. Draghi probabilmente sta deludendo i suoi fans di un tempo e può essere visto come dottor Jekill e mister Hyde: trent’anni fa era un privatizzatore senza paura, oggi è il leader dello Stato regista, imprenditore, garante dello sviluppo.
E tuttavia anche il confronto sul ritorno dello Stato in economia andrebbe rimesso un po’ sui giusti binari, senza esacerbare le posizioni. È vero che la pandemia ha richiamato l’intervento forte delle Istituzioni pubbliche, ma in economia, nell’industria, nei servizi, lo Stato non si è mai ritirato del tutto, anzi. Ha giocato sempre un ruolo importante e propedeutico alla crescita dell’imprenditoria privata, in una combinazione, la famosa “economia mista”, che ha prodotto grandi successi nel Dopoguerra. Le attività economiche pubbliche hanno certamente subito un dimagrimento con le privatizzazioni degli anni Novanta, ma le imprese di Stato non sono scomparse e mantengono un ruolo determinante nell’economia e nel tessuto industriale. Oggi sono saldamente in mano pubblica le quote di controllo di Eni, Enel, Terna, Italgas, Snam, Saipem, StMicroelectronics, Leonardo (già Finmeccanica), Poste Italiane, Fincantieri e Rai. Il perimetro è destinato ad allargarsi. Questa influenza delle imprese di Stato sul sistema la si vede anche nella metamorfosi verso un’economia più sensibile verso l’ambiente e lo sviluppo equo. L’Italia è già oggi il campione dell’economia circolare in Europa, Enel Green Power è il più grande operatore nelle energie rinnovabili, il nostro Paese è il secondo al mondo per export di prodotti green e ancora in Europa siamo i primi esportatori di biciclette (Fonte: Fondazione Symbola).
In passato certamente è mancata, e manca, una riflessione critica sulla lunga stagione delle privatizzazioni, non sempre il passaggio di grandi imprese pubbliche nelle mani dei privati è stato un successo. Come sono andate le banche? Che fine ha fatto Telecom, una delle più ricche e innovative imprese italiane? E l’acciaio? L’Alfa Romeo? I supermercati e la filiera agroalimentare? Che senso ha aprire il trasporto ferroviario alla concorrenza privata se poi alla prima occasione Montezemolo, Della Valle e soci cedono a investitori stranieri e scappano con il malloppo? Una valutazione critica e aperta sarebbe utile anche per evitare errori del passato e sperimentare, magari, opzioni nuove in futuro.
In conclusione: nessuno rimpiange più gli Enti pubblici di gestione, i carrozzoni lottizzati e invasi da partiti e interessi indebiti spazzati via con tangentopoli e il crollo della Prima Repubblica, però il ruolo dello Stato in economia può essere ripensato e rilanciato su basi nuove e coraggiose. Draghi, forse, è la persona giusta in questa congiuntura perché politicamente indecifrabile, ma capace, rispettato e al “servizio del Paese”, che non guasta. Chi s’interroga giustamente sul ruolo di Draghi, politico a sua insaputa o gelido tecnocrate?, dovrebbe chiedersi anche se un’Italia guidata da Conte, Grillo, Salvini o Meloni avrebbe ottenuto gli enormi aiuti europei, di cui abbiamo bisogno come il pane. E poi a chi ancora oggi denuncia e strepita che lo Stato sperpera i soldi di tutta la comunità e che la Cassa Depositi Prestiti diventerà un altro Iri, sarà utile ricordare, per la storia, che quando l’Istituto fondato da Alberto Beneduce venne sciolto nel 2002, dopo aver venduto tutti i gioielli di famiglia, al termine di un lungo e onorato percorso, lo Stato incassò un assegno di ben 24 miliardi di euro. Anche l’Iri, insomma, non era poi così male.
Questo articolo è disponibile gratuitamente grazie al sostegno dei nostri abbonati e delle nostre abbonate. Per sostenere il nostro progetto editoriale e renderlo ancora più grande, abbonati agli Asini.