Le imprese recuperate dai lavoratori in Italia
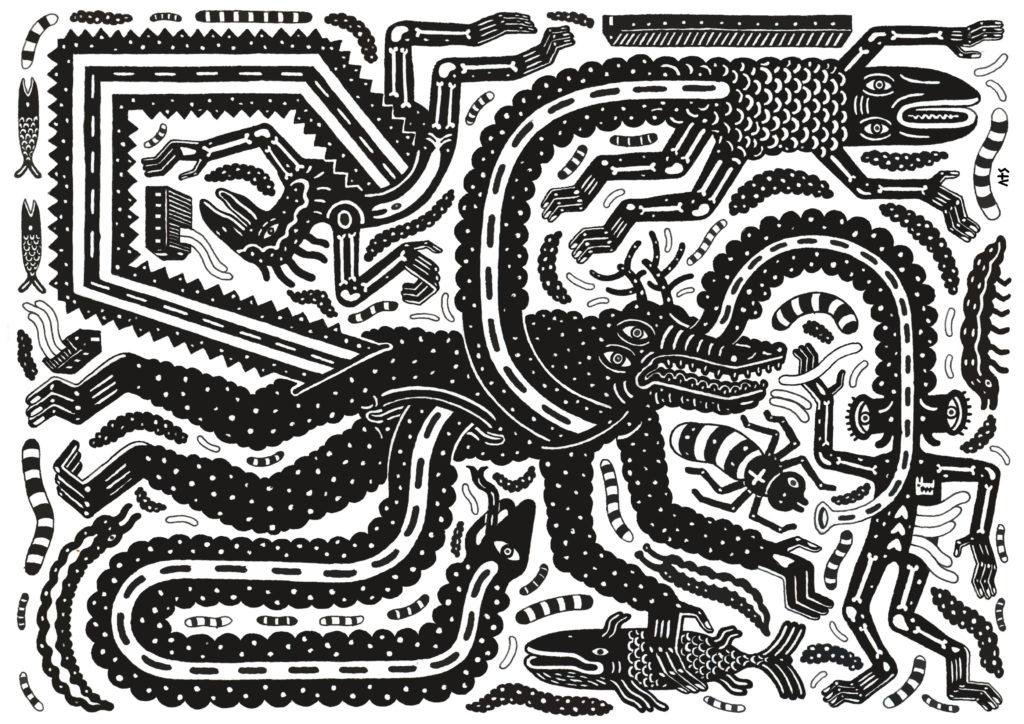
“Ti rendevi conto che i nuovi venuti non erano del mestiere. Non sapevano niente della nostra attività, del nostro lavoro. Erano società finanziarie, fondi d’investimento con sede in Lussemburgo, non interessate alla produttività né agli investimenti. Nei capannoni non si faceva più manutenzione; anche se lo stabilimento non era messo male e bastavano pochi spiccioli per continuare a stare sul mercato. Sempre se… si voglia continuare a giocare pulito! Altrimenti: si smontano i macchinari, si portano in Serbia e noi continuiamo a fare gli straordinari, a riempire il magazzino di scorte. In poche parole, a gonfiare il prezzo della fabbrica che diventa merce appetibile da mettere sul mercato e per noi lavoratori… cassa, mobilità e chiusura all’orizzonte!”.
A parlare è un lavoratore di una delle tante fabbriche della crisi industriale italiana. Di un’azienda fallita dopo l’ennesimo passaggio di proprietà e un altro tavolo ministeriale non andato a buon fine. Un esempio di consapevolezza operaia sulle responsabilità e sul destino del proprio posto di lavoro. Ma è anche il prologo di un’esperienza sociale ed economica più complessa. Si tratta, nello specifico, di un operaio della Mancoop di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina: una cooperativa industriale di 52 soci che ha rilevato dalla curatela fallimentare prima un ramo dell’azienda (ex Manuli, ex Evotape), poi l’intero stabilimento, per continuare la produzione di nastri in gomma-plastica e per riconvertire i 102mila mq, di hangar di produzione e terreni, in un incubatore industriale. Oggi questa cittadella delle attività produttive è in grado di ospitare più di 30 piccole imprese del territorio e offrire loro, a prezzi accessibili, uno spazio con tutte le infrastrutture logistiche necessarie al lavoro di oltre 300 addetti. Questa è una fabbrica recuperata. Qui i lavoratori hanno investito tanto per riconquistare, da soli, il loro diritto al lavoro dignitoso.
L’inchiesta sulla Mancoop è rintracciabile nel sito impreserecuperate.it, frutto del lavoro del Collettivo di Ricerca Sociale, di cui chi scrive fa parte, composto da lavoratori e ricercatori di ogni parte d’Italia, con sede a Torino. Il Collettivo è convinto che ci sia il bisogno di una ricerca partecipata di tipo militante e che restituisca una nuova centralità al lavoro e ai territori. Con questo intento, ha iniziato una lenta opera di comprensione del (e informazione sul) fenomeno del recupero delle aziende da parte dei lavoratori.
Workers buy out, secondo il lessico dell’economia e della finanza o, come noi preferiamo, imprese recuperate.
La Mancoop è infatti solo una delle 120 cooperative di lavoratori che stanno modellando in Italia il fenomeno del recupero industriale. Workers buy out, secondo il lessico dell’economia e della finanza o, come noi preferiamo, imprese recuperate. Oltre alla Mancoop, ci sono la PKarton di Roccavione (Cuneo) che lavora imballaggi in carta, la Screensud di Acerra e la Italcables di Caivano specializzate in reti e cavi d’acciaio. Si producono di nuovo pannelli solari in Sardegna, in Puglia le blocchiere per il cemento, le mattonelle nel distretto di Sassuolo e a Bologna il parquet della Gazzotti. Le imprese recuperate crescono sempre di più e ci indicano quale sia stato il settore italiano a subire maggiormente le ripercussioni delle catene globali del valore. Più del 65% di esse afferisce al settore manifatturiero mentre il restante si divide in aziende di trasporti, farmaceutica, trasformazione agricola e distribuzione. Poche risultano legate alle esperienze del terziario e dei servizi e difficilmente superano i 40 addetti.
In Europa le esperienze di autogestione dei lavoratori nelle fabbriche non sono cosa recente, ma la crisi finanziaria ed economica del 2008 e l’eco delle esperienze sud-americane hanno tributato una rinnovata attenzione al fenomeno. Purtroppo, il più delle volte, esaltandone accezioni contrapposte. Le imprese recuperate sono solo un’altra espressione del mercato che sfrutta l’auto-imprenditorialità dei lavoratori? Oppure una manifestazione salvifica di presunte soggettività operaie? A nostro avviso il fenomeno risulta più articolato e andrebbe analizzato per il suo specifico e, spesso diversificato, portato economico e sociale, per gli strumenti ancora insufficienti che accompagnano le difficili scelte dei lavoratori e, cosa non da poco, per il suo carico ineluttabile di realtà.
L’elemento di partenza dovrebbe essere proprio il percorso che sottostà alla necessità di investire se stessi e quei pochi ma preziosi spiccioli della mobilità e del Tfr, per riappropriarsi della certezza del proprio posto di lavoro. Occupare o presidiare lo stabilimento durante le procedure di concordato o di dismissione, impedire che le macchine vengano prelevate dagli emissari delle curatele fallimentari, trovare la forza e le competenze per stilare un piano industriale, coinvolgere i compagni di lavoro nella costruzione della cooperativa, recuperare i dati per ridurre le asimmetrie informative sulla condizione economica dello stabilimento, imbastire nuove relazioni, incanalare le risorse per il capitale sociale e cercare, ove possibile, investitori istituzionali. Un vero e proprio re-inventarsi nell’unica attività che si è in grado di svolgere: l’operaio specializzato industriale. Quel lavoro che rimane, malgrado le retoriche ottimistiche del neoliberismo e delle politiche attive, è la meno flessibile e ricollocabile tra le occupazioni. Provate un po’ voi a immaginare questo percorso sulla vostra pelle. La vostra riorganizzazione emotiva, quella delle persone che vi sono più vicine, dei vostri tempi, della vostra formazione, della vostra organizzazione quotidiana. Il tutto, con il peso di una rappresentanza sociale e politica disorientata e con le tutele frammentate da anni di attacchi trasversali alle politiche e alle conquiste del lavoro.
“Stavo alla linea della spalmatrice, adesso sono il presidente della cooperativa, ma continuo a fare i turni alla guardiania e mi occupo delle faccende burocratiche, soprattutto non dormo la notte per capire come fare a resistere… per motivare i ragazzi! Qui dovevamo decidere, senza aspettare Godot, che cosa si poteva fare, prima di abbandonarci alla gabbia della cassa…”
Le esperienze di autogestione, tutte quelle che abbiamo incontrato, hanno vissuto queste amare riflessioni decisionali. Perché per loro, lavoratori consapevoli, il percorso che inizia con la cassa integrazione e conduce alla mobilità cela la fine della riconoscibilità e li proietta da un giorno all’altro nell’insicurezza sociale. Allora queste scelte – razionali e complesse, individuali e collettive, di lavoratori per i lavoratori – diventano e sono una reazione sociale a quello che il mercato, lasciato libero di fare, ha distrutto e distrugge. Un mercato, come quello attuale, che sempre più spesso si nasconde nell’alibi delle congiunture sfavorevoli, nei giochi perversi della finanza, nella spregiudicata ragione del profitto da dividere con gli azionisti e che resta, comunque, incapace di riconoscere le vittime lasciate agonizzanti pur di poterlo conseguire.
Le imprese recuperate in Italia sorgono e reagiscono da queste macerie sparse su tutto il territorio nazionale. Come abbiamo visto, nascono nel basso Lazio, nel Sud della Cassa del Mezzogiorno, nel Piemonte fordista e, soprattutto, nei territori luccicanti della Terza Italia del Veneto, della Toscana e dell’Emilia-Romagna. Le imprese recuperate dai lavoratori sono espressione della provincia italiana, lontane dai riflettori dei centri urbani. Fenici, che si trasformano in accusatori diretti – lì dove le persone si riconoscono e si salutano nei bar – delle responsabilità della finanza, degli imprenditori e dei loro manager. Testimoni, che impediscono l’oblio delle statistiche sui fallimenti aziendali e puntano naturalmente l’indice sulle loro rinunce: alla produzione, al lavoro e al territorio. Oggi, dunque, è da queste periferie che si reagisce al capitalismo del mercato autoregolato. Senza esaltare forzatamente l’idea di conflitto, le cooperative di lavoratori che prendono in carico la loro impresa dimostrano, per il solo fatto di esistere, che quello che per qualcuno era da gettar via, e a scarto non compatibile con le nuove vie della competizione, ha ancora una funzione. Che la loro fabbrica, data per spacciata, è ancora in grado di produrre. Magari meno, con un volume d’affari che sta su una scala inferiore, ma consentendo a tante famiglie e alla società di quei territori di programmare di nuovo un futuro; senza fare le valigie e, in tanti casi, con un’attenzione maggiore alla qualità del lavoro e della vita inseriti in scambi di mercato non ossessionati dal massimo profitto.
Le imprese recuperate in Italia sorgono e reagiscono da queste macerie sparse su tutto il territorio nazionale.
Per nascere e resistere le cooperative dei lavoratori impegnati nel recupero hanno bisogno di aiuto. In Italia, oltre al sostegno dei fondi interni delle centrali cooperative, esiste la Legge Marcora (L. 49/1985). Quest’ultima è da considerare, malgrado il silenzio che la contorna, un’importante ossatura politico-giuridica a cui fare riferimento, senza snobismi, quando si parla di imprese recuperate. Giovanni Marcora fu un partigiano e un democristiano che divenne ministro dell’industria nel 1981. La sua figura e l’iter del provvedimento legislativo che porta il suo nome sono stati ampiamente tracciati da Francesco Dandolo – nel libro L’industria in Italia tra crisi e cooperazione. La partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa dall’autunno caldo alla legge Marcora (1969–1985), Bruno Mondadori 2009 – e con essi la rilevante discussione che portò all’approvazione della legge. Questa, generata nel solco del solidarismo cristiano, trovò un’ampia convergenza politica e fu votata anche dal Pci per un’attualissima “esigenza di procedere a una riallocazione delle risorse finanziarie, fino a quel momento utilizzate in modo scarsamente produttivo, quasi esclusivamente dirette a sovvenzionare l’istituto della Cassa integrazione guadagni”. La legge intendeva, inoltre, proporre interventi più concreti sulla partecipazione attiva dei lavoratori, anche di fronte alla deludente portata degli esperimenti pregressi in materia di partecipazione, di democrazia industriale e cogestione.
Oggi questa legge, attraverso la cooperativa Cfi (Cooperazione finanza e impresa, gestore e investitore istituzionale del fondo), incrementa il capitale sociale racimolato con grandi sacrifici dai lavoratori per il recupero dell’impresa dismessa. Dalla ricerca empirica risulta come questo strumento non sia ancora del tutto sufficiente a garantire la serenità dei lavoratori. Va ricordato, infatti, che il fondo originario è stato sostenuto con grandi risultati dal ministero dello Sviluppo economico fino alla metà degli anni Novanta, periodo in cui Confindustria aprì una procedura d’infrazione all’Unione Europea contro la L. 49/1985 perché considerata non conforme alle normative sugli aiuti di Stato. Per i sempre autonomi e impavidi imprenditori italiani lo Stato, che andava a supporto di cooperative di lavoratori che volevano rilevare le loro aziende dismesse e in crisi, avrebbe alterato i regimi concorrenziali del libero mercato. I provvedimenti europei resero inutilizzabile la Marcora per più di sette anni, fino alla promulgazione della L. 57/2001, che recepiva le direttive europee modificando gli articoli 7 e 17 della previgente e riducendo il finanziamento statale da un rapporto di 3:1 a uno di 1:1 rispetto alla co-partecipazione economica dei lavoratori.
Malgrado queste riconosciute “battaglie di equità economica”, la Marcora vive ed è l’unico strumento statale degno di nota a sostegno del recupero aziendale. In quanto tale va considerato quasi come un cortocircuito istituzionale, una condotta inaspettata, un’utile anomalia rispetto alla disarmante complicità tra Stato e mercato a cui siamo stati abituati nell’ultimo trentennio. La visione della Marcora era infatti quella di bilanciare a favore del mutualismo cooperativo industriale i tanti aiuti e finanziamenti concessi ai privati e fino a quel momento utilizzati in modo scarsamente produttivo.
Oltre alla Marcora, va ricordato che ci sono fondi per i Workers buy out attivati da molte regioni italiane. Va segnalato inoltre l’iter incompiuto delle risoluzioni parlamentari n. 7-01024 e 8-00229, presentate e approvate in IX e X Commissione lavoro nel marzo 2017. Il testo di questi atti parlamentari è stato elaborato con il contributo diretto dei lavoratori delle imprese recuperate della Mancoop e della PKarton di Cuneo. La risoluzione conclusiva veicola il lavoro di ricerca del collettivo e accoglie una serie di rivendicazioni strettamente legate alle esigenze verificate dalle esperienze concrete delle realtà del recupero: 1) una maggior semplificazione e pubblicizzazione delle misure legate alla Nuova Marcora (Dm. 4/12/2014); 2) l’organizzazione di un tavolo tecnico istituzionale con rappresentanti dei lavoratori dei Wbo, degli investitori istituzionali, del credito cooperativo, dei sindacati e dell’università; 3) l’aumento dei fondi a disposizione di FonCooper (fondo rotazione 49/85) considerando anche il risparmio statale derivato dalla non attivazione degli ammortizzatori sociali; 4) misure di intervento delle società d’investimento istituzionali atte a rendere le compartecipazioni dei lavoratori meno discriminanti e che tengano conto delle condizioni differenziali nelle aree del paese; 5) l’accesso diretto al Fondo Mise del microcredito per i Wbo riconosciuti dalle statistiche istituzionali o che abbiano le caratteristiche delle cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente che recuperano realtà produttive in procedura di concordato o soggette a fallimento; 6) la previsione di misure agevolate in campo energetico per gli stessi soggetti Wbo. Viene, inoltre, esplicitato in calce che le richieste sono emerse dalla verifica empirica delle pratiche economiche di realtà recuperate da più di quattro anni.
Le cooperative delle imprese recuperate possano essere una valida alternativa al sistema degli scambi economici improntati esclusivamente sulla massimizzazione dei profitti.
Per rispondere alle domande iniziali, dunque, noi crediamo che le cooperative delle imprese recuperate possano essere una valida alternativa al sistema degli scambi economici improntati esclusivamente sulla massimizzazione dei profitti. La ricerca empirica ha dimostrato che le pratiche proposte dai lavoratori indicano come la reciprocità relazionale e la consapevolezza da parte dei lavoratori dei propri mezzi culturali e tecnici possano di fatto ispirare un nuovo modello di soggettività territoriale in grado di connettere le identità dei singoli in nuovi legami sociali e reagire alle disaggregazioni generate del libero mercato. Le imprese recuperate nei territori di tutta Italia sono un fatto sociale ancora da maneggiare con grande attenzione, ma comunque in grado di suggerirci gradi di innovazione sociale e nuove strategie di rivendicazione. Le inchieste condotte dai ricercatori direttamente nelle fabbriche al fianco delle strategie sperimentali dei lavoratori e un’analisi approfondita degli strumenti istituzionali, utili al fenomeno del recupero, restituiscono una cassetta degli attrezzi a disposizione delle forze sindacali, di quelle politiche e di tutti gli attori che non credono sia impossibile l’equilibrio tra riproduzione sociale e produzione. Non vorremmo che queste prospettive restassero solo sulla carta.
La foto è tratta da Farmacia notturna dei fratelli D’innocenzo (Contrasto 2019).