Un perdente
di Alberto Grossi
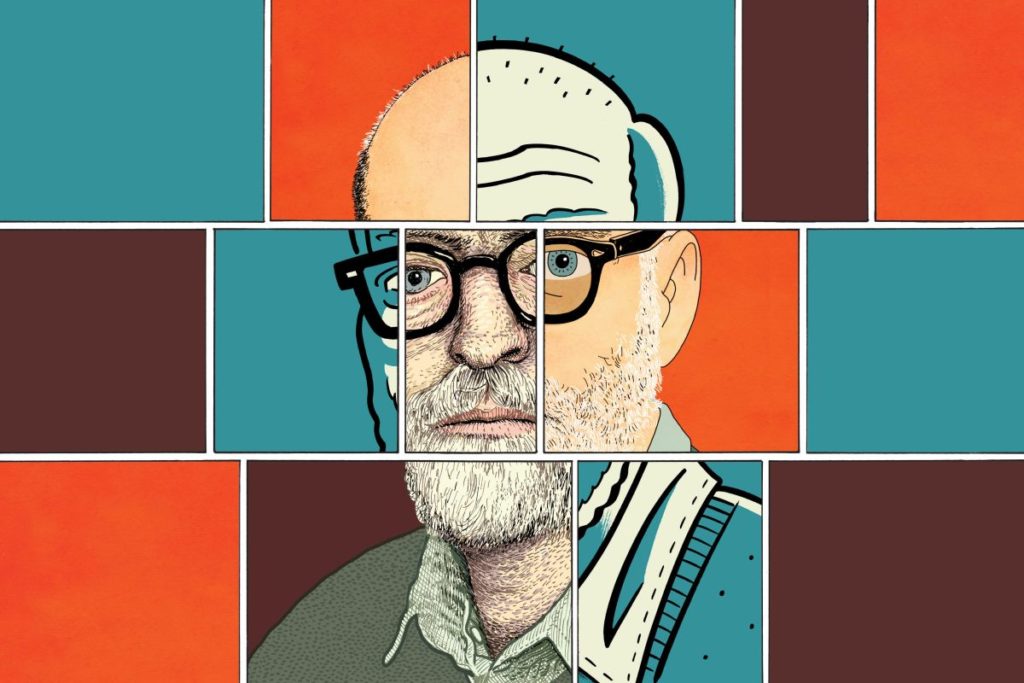
Questo articolo è stato pubblicato sul numero 51 de “Gli asini”: acquista il numero e abbonati per sostenere la rivista.
Avrò avuto dodici anni, forse tredici. Era estate, ero in vacanza all’isola d’Elba con la mia famiglia e un paio di famiglie di amici. Nel residence dove alloggiavamo, al nostro piano, c’erano due ascensori uno accanto all’altro, e come tutti i giorni io e il mio amico pigiammo entrambi i tasti dell’ascensore. Una persona del residence notò la cosa e ci rimproverò. Più tardi i miei genitori andarono garbatamente a chiedere spiegazioni. L’elettricista prima si scusò, poi spiegò che avevamo sprecato energia elettrica, e tra le motivazione addusse il fatto di essere comunista. Che io ricordi, fu quello il primo contatto diretto con una persona di sinistra, per quanto a me sconosciuta. Ne conservo perfettamente lo sguardo severo e fiero dietro ai baffi folti. In quegli anni, scoprirò poi, Enrico Berlinguer parlava di austerità e questione morale.
Verso i diciannove anni iniziò a formarsi la mia coscienza politica. Diventai di sinistra quasi naturalmente, per convinzione intima di essere nel giusto ma anche in opposizione a una destra che consideravo conservatrice e reazionaria e che, all’Università Cattolica di Milano che frequentavo, occupava ogni spazio possibile. In quegli anni imperversava Cossiga presidente della Repubblica, che ogni giorno sbeffeggiava la sinistra con insolenza e protervia. Il maggiore partito di sinistra, allora, era guidato da un leader timido, Achille Occhetto, che noi avvertivamo distante e quasi con fastidio ma che in fondo rispettavamo. C’era ancora, più vivo che mai, Bettino Craxi, che ogni tornata elettorale aumentava i propri voti drenandoli dai comunisti. Fuori dal palcoscenico ufficiale dei partiti la mia appartenenza alla sinistra si consolidava, sentivo di essere dalla parte giusta della barricata.
Ricordo una festa dell’Unità, nella mia città, Parma, una sera di luglio e un’orchestrina che suonava Bandiera Rossa e la strofa finale magicamente cambiò in “evviva il pidiesse e la libertà”. Già, il Pds. Erano i tempi della guerra del Golfo, e il mondo pacifista si divideva: via diplomatica o azione militare per ripristinare la sovranità del Kuwait? L’anno successivo deflagrò la crisi in Jugoslavia. Ricordo Oliviero, un compagno di università di Piacenza che una mattina a lezione ci comunicò che sarebbe partito per una marcia pacifista verso la Sarajevo assediata. Sarebbe passata alla storia come la marcia dei cinquecento. Bella, nobile, controversa, irrisolta, audace e contraddittoria, quella marcia rappresentò bene il generoso e confuso mondo del pacifismo italiano. Negli anni a venire, ne avrei incontrati almeno un migliaio che dicevano di aver partecipato a quella marcia dei cinquecento! Battute a parte, furono per me gli anni decisivi nella formazione politica. Scrivevo per riviste di area ecologista pacifista, leggevo libri, incontravo centinaia di persone, partecipavo a marce, meeting e convegni, guidavo furgoncini diretti ai campi profughi lungo la costa dalmata e mi sporcavo le mani in progetti belli e importanti tra cui uno di accoglienza per disertori della ex Jugoslavia: fermiamo un fucile alla volta, si chiamava.
Mi iscrissi ai Verdi nel 1996 quando Luigi Manconi ne diventò l’illuminato portavoce. Erano anni tribolati ma di governo sotto le insegne dell’Ulivo, nel perimetro del centrosinistra. Credevamo in una svolta ecologista per il nostro paese, più risorse per l’ambiente, contro il dissesto idrogeologico, un nuovo rapporto uomo natura. Ma entrare nella stanza dei bottoni, sia pure lateralmente, smosse purtroppo ben poco. Rimasi iscritto un paio d’anni, giusto il tempo di assaporare il disgusto delle pratiche interne ai partiti. Quando D’Alema scalzò Prodi qualcosa incominciò a rompersi. Sugli immigrati, ad esempio, la sinistra di governo oscillava tra un buonismo futile e ingenuo e una nuova, insolita, cattiveria. Era evidente, come scrissero alcuni, che si scontava un pesante “deficit di elaborazione culturale”. La nostra sinistra, la sinistra sociale fatta di movimenti, associazioni e cooperative, godeva ancora di buona salute, un po’ di soldi per fare qualche bel progetto giravano ancora.
Ricordo il direttore di una struttura residenziale per anziani nelle Marche. Eravamo al telefono quando venne chiamato di fretta dai colleghi, lui riattaccò. Mi richiamò qualche ora più tardi spiegandomi che c’era stato un decesso in struttura. Gli feci notare che lavorava tanto e lui mi rispose, lavoro il doppio del tempo mio a contratto e sai perché? Perché sono comunista. Pensai fosse molto bello tutto ciò. Eppure, con indosso il cappellino del comunista ne vedevo di ogni tipo. C’era il cinico burocrate attento solo a difendere il perimetro del suo piccolo potere, il sindacalista impegnato nel mantenere aperte le questioni senza risolverle, l’imboscato in qualche settore del pubblico, il velleitario inconcludente interessato solo alla propria visibilità. Anche a livello locale i nuovi dirigenti di sinistra erano riconoscibili più per la furbizia che per i valori o la preparazione che esprimevano. Così, facendo forse finta di non vedere perché ci avrebbe fatto male, accanto a noi cresceva e si moltiplicava la nuova sinistra, rampante, vorace, grandi cooperative più concentrate sulla finanza che sulla produzione (“abbiamo una banca” dirà Fassino), dove la distanza tra lavoratori e dirigenti si faceva ogni giorno sempre più ampia. I nuovi dirigenti esibivano muscolarità, ascoltavano poco e pretendevano rispetto e devozione. Era nata la sinistra autoreferenziale. Quella che si commuove ai concerti della Mannoia ma che ignora le periferie, la gente che fa fatica.
Nel 2007 nacque il Pd e a guidarlo c’era Veltroni e la sua “vocazione maggioritaria”. Per qualche tempo ci illudemmo che la sua presenza mediatica sarebbe stata taumaturgica, ma sbagliavamo, perché non esiste che si copra con una bella comunicazione una progettualità esile se non evanescente. Da lì ai giorni nostri, passando da Bersani a Renzi, il giochino della “ditta” è stato sempre il solito: mettere su un leader nuovo, acclamarlo, investirlo del ruolo di salvatore della patria e infine andarsi a schiantare alle elezioni non capendo che il paese profondo, la gente comune, non ci segue più. Ricordo una manifestazione Pd in quegli anni veltroniani in piazza Maggiore a Bologna, io e un amico ci guardammo intorno: oltre a noi c’erano solo anziani. In prima fila solo una piccola pattuglia di trentenni, lo sguardo nitido di chi ha già programmato la carriera nel partito. La trasformazione da partito di massa a partito delle élite era completata.
Nel 2008 vinse nuovamente Berlusconi, quattordici anni dopo la sua discesa in campo. Penso che nessuno uomo politico abbia stimolato in me tali e tanti pensieri di disprezzo e ripugnanza, talvolta di odio, eppure a molti anni di distanza credo che il suo sia stato un capolavoro di marketing politico. Ha perseguito politiche di destra e interessi particolari e aziendali raccogliendo il voto di disoccupati, di gente semplice, di persone che hanno proiettato su di lui la speranza di migliorare la propria esistenza. Ha dato loro un piccolo sogno, per quanto mai realizzato. Certamente li ha illusi, ma per qualche mese hanno avuto un appiglio, anche solo una fantasia. I miei leader di sinistra, a pensarci bene, nemmeno quello.
Oggi ho quarantacinque anni, due figlie da mantenere, un mutuo prima casa da onorare, un lavoro indipendente che per fortuna mi piace ancora e che mi fa campare in modo dignitoso ma mi costringe a essere estremamente prudente e oculato in ogni singola spesa. Però mi guardo attorno e vedo i disastri compiuti o avallati anche dalla sinistra di governo, ma non solo. Lo vedo in molti dipendenti dello Stato, che passano il tempo a lamentarsi pur avendo stipendi abbondanti e garantiti. Lo vedo nella sanità, che spesso spreca e che passa prestazioni gratuita anche a chi imbroglia, tanto nessuno controlla. Lo vedo nella scuola, incartata su se stessa e che ricorre a psicologi e poliziotti per spiegare cose che un buon insegnante dovrebbe sapere, ad esempio come usare correttamente i social network. Lo vedo nel nostro ambiente, sempre più inquinato. Lo vedo nelle truffe all’Inps dei ricongiungimenti famigliari per intascare assegni e sussidi, anche tanti stranieri hanno imparato il giochino. I miei, i nostri grandi temi politici, ambiente e diritti ad esempio, sono spariti dal radar della politica e traditi: se ne sono impossessati quattro ragazzotti senza arte né parte che, a forza di cavalcarli, hanno anche vinto le elezioni politiche. I miei leader politici di sinistra hanno perlopiù inseguito un industrialismo superato, inefficiente e inquinante (vedi Ilva di Taranto, trivellazioni nell’Adriatico, centrali a carbone) sostenendo solo in piccola misura un’idea di industria pulita e hi-tech. Quando osservo le immagini aeree della mia pianura padana, una gigantesca macchia grigia che ci soffoca, mi assale il senso vero della mia, della nostra sconfitta.
Il vero dramma lo percepisco quando guardo alla mia cerchia di relazioni. Ho visto una intera generazione, quella dei venticinque/trentenni, scappare all’estero per disperazione tentando di far valere i propri titoli di studio. Ho visto la mia generazione, quella dei quarantenni, perdere lavoro e riciclarsi in altri molto meno qualificati, ma almeno la sfangavano con uno stipendio, altri sono ancora alla ricerca. Vedo coetanei morire di tumore nel giro di pochi mesi, e i commenti ai funerali sono sempre gli stessi: “che peccato, era così giovane”. Nessuno che si interroghi sulla relazione che c’è fra l’ambiente che abbiamo creato e il “brutto male” che miete vittime?
Questo articolo è stato pubblicato sul numero 51 de “Gli asini”: acquista il numero e abbonati per sostenere la rivista.