Morire sul lavoro nel distretto di Prato
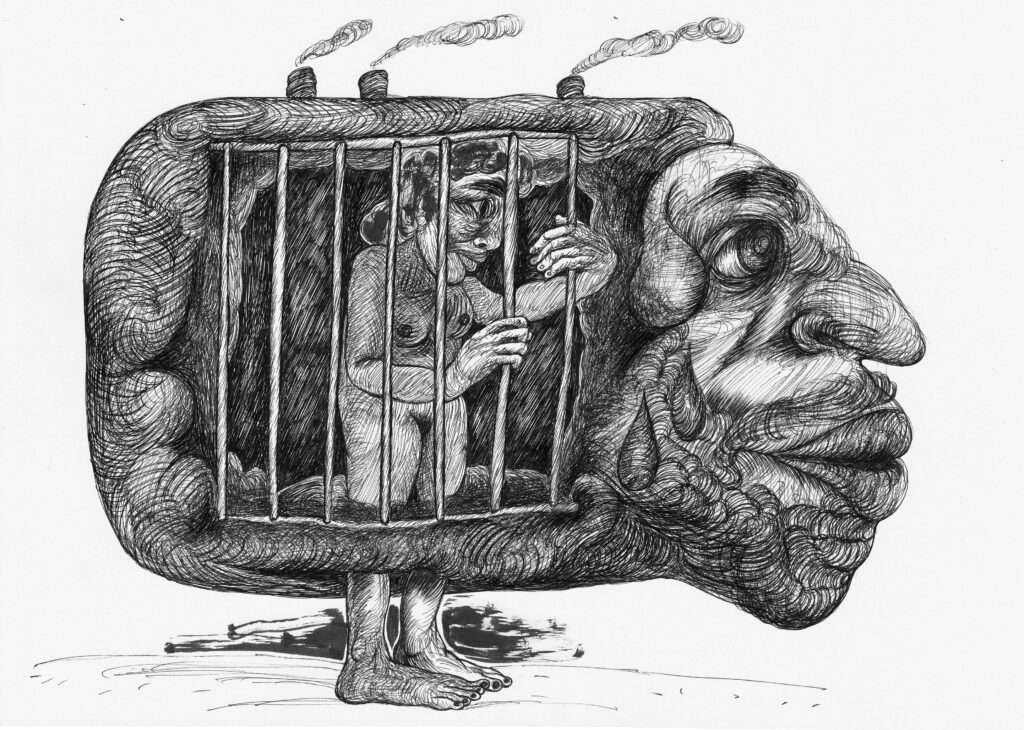
illustrazione di Majid Bita
1 Luglio 2021
Chi percorreva la pistoiese o la montalese nell’attraversamento di paesi e borghi era accompagnato dal ritmo dei telai.
Educazione e intervento sociale
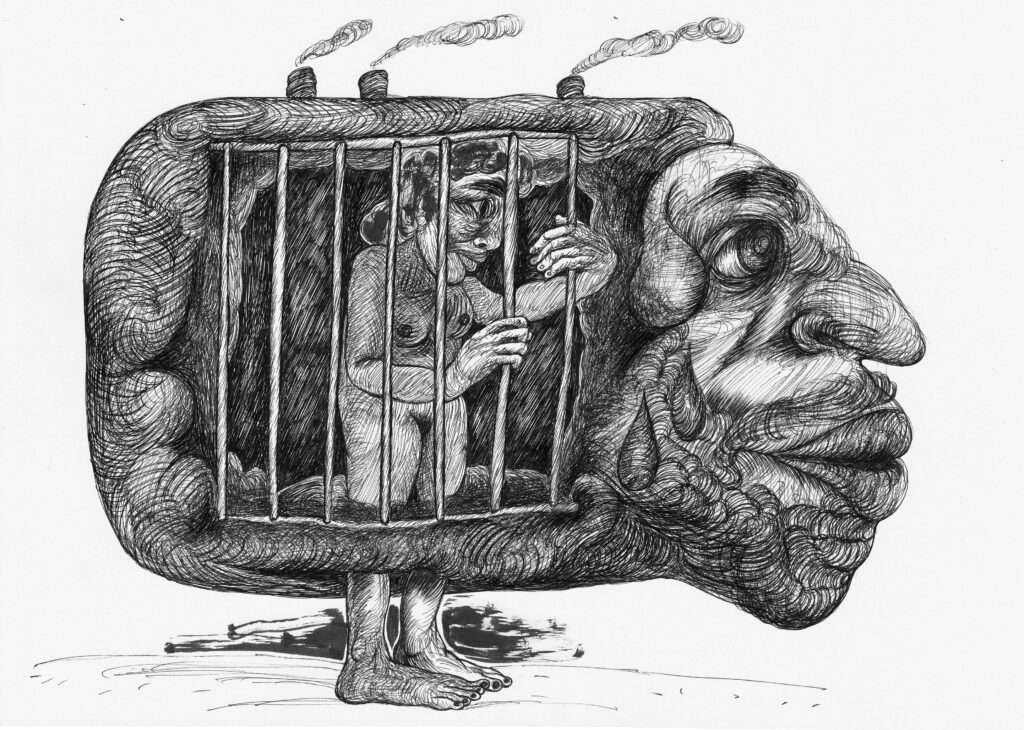
Centro di Documentazione di Pistoia
via Pertini snc, c/o Biblioteca San Giorgio – 51100 Pistoia
p.iva 01271720474 – codice destinatario KRRH6B9