Economia e mafie. Il riciclaggio del denaro sporco
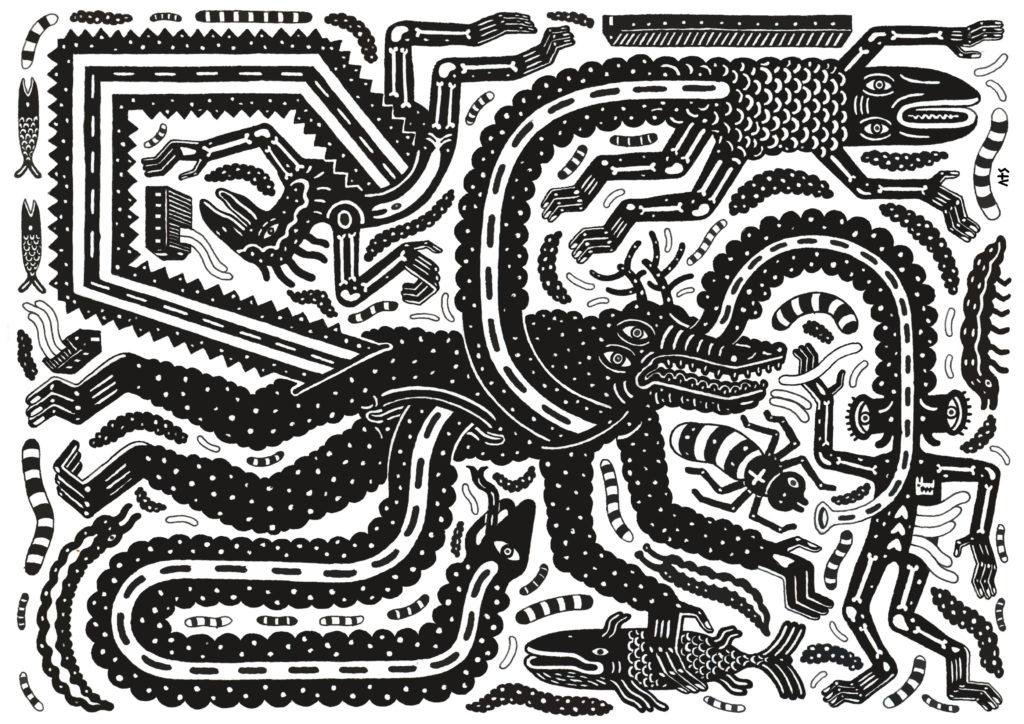
(disegno di Andre The Spider)
La storia dell’umanità, com’è noto, è segnata fin dall’inizio da un furto e dalla trasgressione di una norma. Ma quel furto di mela da parte di Adamo ed Eva non rese ricchi gli autori né consentì che il bene sottratto divenisse fattore produttivo, e non determinò affatto un allargamento dei benefici oltre i “colpevoli”. L’attività predatoria, infatti, in genere non incide sull’economia, non mette in moto un circuito produttivo, ma si limita alla sottrazione di un bene che viene goduto da un soggetto diverso dalla vittima che legittimamente lo possedeva. L’economia classica quando si riferisce al crimine lo identifica con le attività predatorie che danneggiano la proprietà privata, la quale rappresenta la base fondamentale e imprescindibile dell’economia di mercato. Stuart Mill, in particolare, scrive nel 1848 in Principi di economia politica che la criminalità non dà luogo a produzione, perché essa “distrugge e non crea ricchezza”. Ma è proprio così? A prima vista impresa produttiva e criminalità, delinquenza e mercato, capitale e reato sembrano termini assolutamente inconciliabili nella teoria economica classica. Il mercato capitalistico moderno si è formato proprio in quanto ha espulso da esso le fasi e le prassi violente e predatorie, e si è consolidato quando ha reso sicuri gli scambi commerciali dando certezza agli operatori economici che le loro merci non sarebbero state prede dei pirati (per via mare) o dei banditi (per via di terra, nelle foreste tra città e campagna).
La storia dell’umanità, com’è noto, è segnata fin dall’inizio da un furto e dalla trasgressione di una norma.
La sicurezza negli scambi viene garantita dal monopolio della violenza in mano agli Stati nazionali, e tale monopolio permette l’allargamento del mercato prima su scala nazionale e poi su quella internazionale. È del tutto evidente che lo stimolo a produrre più merci (al di là della domanda locale) si realizza a condizione che la collocazione di quelle stesse merci in mercati lontani non sia impedita da predatori. Per Stuart Mill, dunque, la criminalità è ancora e solo un’attività predatoria, che sottraendo la ricchezza a qualcuno e passandola a qualcun altro non incide sullo sviluppo della ricchezza stessa ma solo sulla sua diversa distribuzione. Insomma, la criminalità opera un semplice spostamento dei beni, senza effetti significativi sulla società, che non diventa più ricca o più povera a causa delle azioni illegali o criminali. Di questa visione, prima di Stuart Mill, si era fatto alfiere il francese Jean-Baptiste Say, il maggiore esponente del pensiero economico classico fuori dall’Inghilterra. Egli sostiene che un guadagno fraudolento potrà essere considerato un’ingiustizia dal moralista ma per l’economista si tratterà solo di uno spostamento di ricchezza. “Un furto, una perdita al gioco d’azzardo e altri accidenti, fanno passare una porzione di ricchezza da una mano all’altra” senza che la società e l’economia nel loro complesso ne risentano. In questa visione, dunque, il crimine è un evento limitato e circoscritto, “una vicissitudine” particolare senza conseguenze generali. È Say a sancire in dottrina l’irrilevanza economica dei crimini predatori.
Purtroppo gli economisti classici (e non) sono stati clamorosamente smentiti dalla storia. Eppure, nonostante le ripetute smentite, sono rimasti per lungo tempo in silenzio, in preda a una rimozione profonda del valore economico del crimine, della sua capacità di andare ben oltre l’aspetto predatorio e trasformarsi in uno dei protagonisti dell’economia contemporanea. Essi rifiutano di considerare il crimine come una variabile di non poco rilievo dell’economia, e spesso danno l’impressione che la questione criminale non li riguardi. Appare oggi del tutto evidente, tranne che alla maggior parte degli economisti, che l’economia criminale è contro le leggi degli Stati ma non contro quelle dei mercati, mentre nel pensiero economico classico prevale il convincimento di una certa “neutralità” del crimine, che in ogni caso non può allargarsi oltre le attività predatorie, non può rappresentare una minaccia per il buon andamento dell’economia. E per questi motivi non è oggetto di studio.
Insomma, c’è un imbarazzo degli economisti a trattare la materia. Ma questo imbarazzo non è motivato scientificamente. La criminalità ha a che fare con l’economia, anche con quella produttiva, e nasconderlo o minimizzarlo sarebbe antistorico e antiscientifico. Infatti, contrariamente ai dettami del pensiero economico dominante, le attività criminali non sono classicamente improduttive, predatorie o parassitarie. E ciò che definiamo economia illegale, non vuol dire che automaticamente non sia sostenuta da uno sforzo imprenditoriale. Tra illegale e imprenditoriale e tra illegale e produttivo non c’è nessuna contrapposizione insanabile.
Appare oggi del tutto evidente, tranne che alla maggior parte degli economisti, che l’economia criminale è contro le leggi degli Stati ma non contro quelle dei mercati
La confusione e l’imbarazzo che regna negli ambienti economici internazionali su come classificare il crimine è dimostrata da una recente e clamorosa decisione dell’Unione Europea. Dal 2014 i Paesi dell’Europa, su indicazione di Eurostat, l’Istituto statistico europeo, hanno potuto inserire alcune attività illegali nel calcolo del Pil, in particolare prostituzione, droghe e contrabbando di sigarette. Lo scopo è di dare “stime esaustive” che comprendano “tutte le attività che producono reddito, indipendentemente dal loro status giuridico”. Si sancisce, cioè, che le attività criminali danno il loro contributo all’economia e, sembra incredibile, alla “virtuosità” di bilancio dei Paesi europei.
È come se l’Europa si fosse resa conto che nella dimensione imprenditoriale non esiste un confine sicuro, certo e invalicabile, tra attività legali e illegali. E non basta la morale o la religione a porre limiti e barriere.
L’economia è molto più aperta della rigida regolazione della legge, come abbiamo già scritto. Si può fare economia anche fuori o addirittura contro la legge: la classificazione ai fini del Pil di attività monopolizzate da organizzazioni criminali lo ha sancito in maniera inequivocabile. Siamo di fronte a una legittimazione del ruolo economico delle attività mafiose. Con un piccolo particolare: queste attività sono formalmente e giuridicamente illegali, cioè contro le leggi degli stessi Stati che le calcolano nel loro Pil, nella loro ricchezza. Le mafie dal 2014 fanno parte della ricchezza dell’Unione Europea!
Ma è bene ricordare che i reati economici non sono monopolio delle mafie. Anzi. E le mafie rappresentano solo una parte dell’economia illegale che certamente è funzionale e incoraggiante per quella mafiosa, anche se non sono la stessa cosa. I mafiosi, dunque, sono solo alcuni degli attori dei reati economici. Riciclaggio, evasione fiscale, lavoro sommerso, corruzione non hanno il marchio “mafie”, anche se i capi di Cosa nostra, camorra e ’ndrangheta praticano gli stessi circuiti illegali e usano le stesse tecniche legali usate dagli evasori fiscali, dai corrotti e da tutti coloro che hanno interesse a occultare la propria ricchezza. Il mezzo (riciclaggio) e il fine (occultamento per potere reinvestire o utilizzare e godersi legalmente quanto è stato nascosto) sono uguali. Cambiano solo i soggetti o le definizioni di essi (corrotti, corruttori, evasori, criminali, mafiosi). Senza il grande campo dell’economia illegale non si potrebbe spiegare il successo delle mafie nell’odierna economia globalizzata.
Ma quanto vale l’economia illegale, in Italia e nel mondo?
Darne una misurazione precisa non è facile. I calcoli non sono semplici, perché parlare di economia illegale significa parlare di attività economiche che sfuggono alla legge, e per questo motivo le stime di esse possono essere solo approssimative. In gran parte i dati derivano da quanto viene scoperto dalle Forze dell’ordine e quindi il fenomeno è in genere sottostimato. Ma alcune cifre fornite da attenti osservatori sono davvero imponenti, impressionanti.
Secondo Eben Shapiro, giornalista del “Wall Street Journal”, ben il 70% di ciò che circola nelle borse di tutto il mondo deriva dall’economia illegale! Secondo, poi, una stima di qualche anno fa della Banca mondiale, il denaro illecito che transita in gran parte delle banche dei Paesi occidentali e sui mercati finanziari internazionali si aggira sui 1.600 miliardi di dollari. Il peso dell’economia non osservata è in Italia pari al 20,6% del Pil, cioè più di 310 miliardi di euro, un quinto dell’economia italiana. Nel solo Sud vale poco più di 100 miliardi di euro (il 28,6% del Pil). Certo, il dato complessivo è nettamente superiore a quello stimato dall’Istat nel 2011 (12,4% del Pil) e nel 2014 (13%). Ma, se a questo dato si aggiunge l’economia strettamente criminale/mafiosa nel nostro Paese, oltre a quella già calcolata nel Pil, si arriva nettamente al di sopra di un quarto dell’economia italiana! La dimensione del riciclaggio secondo dati del 2015, in Italia supera il 10% del Pil. “Con un fatturato di 150 miliardi di euro, dunque, la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come Eni!” ha sostenuto in un suo libro Piero Grasso.
C’è un altro dato da cui è possibile ricavare elementi importanti a proposito del peso dell’economia illegale: le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio all’Uif (Unità di informazione finanziaria, operante presso la Banca d’Italia). Naturalmente segnalazione non è sinonimo di reato, ma i numeri sono davvero imponenti. Tra il 2007 e il 2014 ce ne sono state ben 325mila da parte di intermediari finanziari, professionisti e altri operatori privati, di cui 70mila solo nel 2014. Si tratta di uno dei dati più elevati in Europa, con la Lombardia e il Lazio che precedono ampiamente in classifica le regioni a più alta presenza mafiosa. È un numero che aumenta di anno in anno. Quasi il 90% delle segnalazioni alle autorità viene dai notai, mentre totalmente assenti sono quelle degli avvocati, degli agenti immobiliari e delle case d’asta. In generale si riscontra (sono parole di Banca d’Italia) “il ricorso massiccio al contante, a sistemi di false fatturazioni, all’utilizzo di schermi societari e di intestazioni fittizie; abituale è la frammentazione delle operazioni, che innesca, in sequenze temporali di difficile interpretazione, vorticosi trasferimenti fra aree geografiche anche molto distanti e tra settori non omogenei. Spesso appare quasi inestricabile l’intreccio tra profitti delle attività criminali e profitti di attività imprenditoriali acquisite originariamente con capitali riciclati ma poi gestite con modalità lecite.”
Quasi il 90% delle segnalazioni alle autorità viene dai notai, mentre totalmente assenti sono quelle degli avvocati, degli agenti immobiliari e delle case d’asta.
Nell’epoca dell’economia globalizzata e finanziarizzata è più evidente l’egemonia del potere economico su quello politico e la separazione quasi definitiva dell’economia dal diritto. La fine degli Stati nazionali e delle economie nazionali ha rappresentato, come si è detto, anche la fine del compromesso storico tra regole ed economia, tra diritto e mercato. Mentre dentro gli Stati nazionali il tentativo del diritto di regolare il mercato, di contenere le sue manifestazioni più animalesche e la sua sostanziale amoralità, in parte era riuscito, dentro l’economia globalizzata il mercato si è tolto definitivamente da dosso il cappio o le briglie del diritto. Il mercato si è così trasformato in un “non luogo del diritto”, sicché sembra corretto affermare che “il capitalismo finanziario della globalizzazione ha sconfitto definitivamente, almeno per ora, il diritto”, come hanno scritto Paolo Prodi e Guido Rossi in un loro saggio.
E di ciò ne hanno approfittato le criminalità organizzate. La maggiore presenza nell’economia globalizzata di esse (come mai era avvenuto all’interno delle economie nazionali) è una delle conseguenze, non la sola naturalmente, del divorzio netto tra diritto e mercato.
Quello che risulta maggiormente inquietante è che le più terribili architetture finanziarie che hanno messo in ginocchio migliaia di risparmiatori o che hanno illuso milioni di compratori a debito sono avvenute “non nella violazione, ma nel pieno rispetto delle regole del mercato finanziario”.
Gran parte della finanza illecita o criminale è stata finora protetta dal segreto bancario e dall’uso improprio del diritto alla privacy attraverso reti occulte che trasferiscono enormi quantità di denaro in tutti i Paesi dell’economia globale, soprattutto da e verso i cosiddetti “paradisi fiscali”.
E nei “paradisi fiscali” ci sono ben 10mila sedi di banche! E cosa sono i “paradisi fiscali”?
Efficacemente Vincenzo Visco ha affermato: “Sono luoghi a bassa o nulla tassazione in cui è possibile collocare i propri risparmi in condizioni di sicurezza”. Ma le loro funzioni sono molto più ampie. Essi infatti forniscono condizioni di segretezza, la possibilità di eludere la regolamentazione finanziaria (relativa alle società per azioni, alle banche, alla borsa, alle assicurazioni) e di aggirare la normativa di altre giurisdizioni (per esempio in materia di riciclaggio, eredità, divorzio). Servono a “riciclare o ripulire capitali di dubbia provenienza, a garantire l’anonimato dei titolari, a evitare il pagamento delle imposte, a eludere le normative nazionali, a poter operare in un contesto privo di regole e controlli”. Secondo Nicholas Shaxson, giornalista britannico, autore del libro Le isole del tesoro, più della metà del commercio mondiale passa, almeno sulla carta, attraverso i “paradisi fiscali”. Oltre la metà di tutti gli attivi bancari e 1/3 dell’investimento diretto estero effettuato dalle imprese multinazionali vengono dirottati off-shore. Circa l’85% delle emissioni bancarie e obbligazionarie internazionali si svolgono nel cosiddetto “euromercato”, una zona off-shore extraterritoriale. Le risorse collocate nei “paradisi fiscali” “derivano per 1/3 da attività criminali in senso stretto, per alcuni punti percentuali da proventi della corruzione, e per la parte restante da evasione ed elusione fiscale. In altre parole nei ‘paradisi fiscali’ soldi ‘puliti’ non ce ne sono, e quindi il silenzio è essenziale”.
I “paradisi fiscali” possono essere classificati in tre gruppi principali: quelli europei (Svizzera, Lussemburgo, Olanda, Liechtenstein, Austria, Belgio, Principato di Monaco, San Marino, Andorra, Madeira, Cipro, e il Vaticano (tramite la sua banca, lo Ior); quelli che fanno capo alla Gran Bretagna e a tutte le nazioni dell’ex impero britannico, che sono estensioni ed emanazioni della City londinese (Jersey, Guernsey, l’Isola di Mann, Gibilterra, le Isole Cayman, Bermuda, le Isole Vergini Britanniche, le Isole Turks e Caicos). Nell’area di influenza britannica ci sono pure Paesi come Hong Kong, Singapore, le Bahamas (qui già negli anni Trenta il criminale americano di origine ebraica Meyer Lansky, l’inventore di Las Vegas come città del gioco, riciclava i proventi della mafia americana), Dubai e l’Islanda; quelli che fanno capo agli Stati Uniti: alcuni stati americani (il Delaware, il Wyoming, il Nevada, il South Dakota) e Paesi legati agli Usa quali le Isole Vergini Americane, le Isole Marshall, la Liberia, e soprattutto Panama, che è diventata la centrale del riciclaggio dei narcodollari. Questo sistema off-shore è di fatto controllato dalle principali banche del mondo: dieci di esse hanno contribuito fortemente a crearlo (Ubs, Credit Suisse, Goldman Sachs, Bank of America, Hsbc, Bnp Paribas, Wells Fargo, Morgan Stanley/Ssb, JP Morgan Chase). L’entità della ricchezza detenuta off-shore è stimata tra 21mila e 32mila miliardi di dollari, ben al di là dei 18mila miliardi che rappresentano il Pil degli Stati Uniti.
I “paradisi fiscali” possono essere classificati in tre gruppi principali: quelli europei, quelli che fanno capo alla Gran Bretagna e a tutte le nazioni dell’ex impero britannico e quelli della finanza off-shore
La finanza off-shore di per sé non è criminale, ma favorisce le reti criminali con le sue “libertà”, costituendo “buchi neri perfettamente leciti che sfuggono ai controlli della autorità giudiziarie”. Infatti con tali società spesso si nascondono perdite di bilancio o altre operazioni illecite e si dà vita a speculazioni o riciclaggio che passano quasi sempre attraverso i “paradisi fiscali”. Questi ultimi, grazie alla tassazione fortemente ridotta sui redditi, danno tutela e rifugio alla criminalità di tutto il mondo, attirando molti capitali nelle loro banche, le quali, peraltro, e questo non è un dettaglio né una informazione di minore importanza, hanno un segreto bancario molto rigido. Ciò significa che tali istituti bancari non sono tenuti a rendere conto della provenienza del denaro: le transazioni sono coperte, non c’è trasparenza e soprattutto non c’è scambio di informazioni con gli altri Paesi.
I “paradisi fiscali” quindi sono “neutrali”, assolutamente indifferenti all’origine dei capitali. Accolgono tutto il denaro senza discriminazione: quello criminale, quello legale e quello mafioso. “Quando un capitale di provenienza sospetta prende le strade di un pacchetto azionario, di una tranche di buoni del tesoro, di un complesso immobiliare, diventa semplicemente un capitale, destinato a riprodursi, a creare nuove ricchezze”. Infatti è proprio attraverso il passaggio per tali Paesi che il danaro mafioso torna poi pulito a disposizione dei boss in Italia. Non è un sistema sorto per i mafiosi o da loro inventato, anche perché si tratta di meccanismi che richiedono l’attività di specialisti in grado di organizzare il percorso dei soldi e di seguirli fino al capolinea. È una pratica nata per i ricchi che nei “paradisi fiscali” hanno trovato un sistema per godere del proprio danaro senza dover essere soggetti a tassazioni, sistema che oggi certamente i mafiosi utilizzano. Rispetto ai loro colleghi non criminali, però, pagano un prezzo per tale pratica, perché il passaggio per i “paradisi fiscali” è nel loro caso quasi sempre finalizzato al riciclaggio e riciclare ha un costo, tanto che si potrebbe parlare per i mafiosi più che di paradisi di “purgatori fiscali”. Purgatori di cui i mafiosi non possono fare a meno: hanno bisogno del riciclaggio che è il nucleo stesso della criminalità organizzata, poiché senza il riciclaggio il denaro delle mafie sarebbe un ricavato “inerte”, come efficacemente sostiene Piero Grasso: “I proventi criminali hanno un potere di acquisto solo potenziale che il riciclaggio ha la funzione di trasformare in effettivo. Il riciclaggio rappresenta, inoltre, un ponte fra criminalità e società civile che offre ai criminali gli strumenti per essere accolti e integrati nel sistema, arrivando a sedere nei consigli di amministrazione e a contribuire all’assunzione di decisioni economiche e sociali rilevanti”.
È nel riciclaggio che si opera la più grande contiguità tra sistemi criminali e meccanismi legali e illegali di gestione del danaro, ed è il riciclaggio la più grande dimostrazione che tutto l’armamento costruito per occultare le ricchezze e favorire l’anonimato si è dimostrato assolutamente funzionale ai giochi delle mafie.
L’economia finanziaria opaca ha favorito le mafie, dimostrandosi oggi più congeniale alle strategie di occultamento della ricchezza e del suo riciclaggio da parte della criminalità rispetto a tutte le epoche precedenti. Mai era stato consentito a proventi della criminalità di avere così libero corso come oggi. In nessun’altra epoca storica. In questo circuito il denaro illecito, in qualsiasi forma accumulato (con la corruzione, con il furto, con l’evasione fiscale, con le varie manipolazioni societarie e finanziarie possibili, con la violenza usata dalla criminalità organizzata) diventa denaro riutilizzabile legalmente. La criminalità organizzata segue la stessa strada di altre forme di ripulitura del denaro, utilizza gli stessi canali che vengono usati normalmente da speculatori, da imprenditori o redditieri senza scrupoli, o per meglio dire dalle élite ricche e potenti di tutto il mondo capitalistico. Il peso avuto dalla libera circolazione dei capitali senza vincoli nazionali è stato decisivo. La liberalizzazione dei capitali ha implicato un effetto indesiderato: la straordinaria possibilità dei proventi criminali di occultarsi, pulirsi e riciclarsi. È, dunque, la necessità di occultare il denaro ad avere aperto la strada alla criminalità verso il panorama economico internazionale. È per questa via che le mafie sono divenute protagoniste del capitalismo finanziario, ottenendo legittimazione con gli stessi metodi con cui si assicuravano profitti alle classi già ricche.
E fondamentale per il riciclaggio è il funzionamento permissivo dei circuiti bancari e finanziari. Si possono considerare tre fattispecie al riguardo: la banca è consapevolmente coinvolta per ragioni di profitto (intermediario inquinato); la banca non esercita un controllo serio sulle transazioni (intermediario inefficiente); non è la banca ma il singolo impiegato a colludere (intermediario inconsapevole). In tutti e tre i casi si dimostra che l’attuale funzionamento delle istituzioni bancarie e finanziarie è esposto a fini di riciclaggio di denari della malavita.
E fondamentale per il riciclaggio è il funzionamento permissivo dei circuiti bancari e finanziari.
Dunque, l’industria bancaria e finanziaria rappresenta uno snodo fondamentale per la possibilità che i proventi da evasione fiscale, da corruzione o da attività criminali possano essere riciclate e ripulite. Il riciclaggio bancario e finanziario svolge una funzione essenziale nella crescita dell’attività criminale complessiva, compiendo l’operazione fondamentale affinché i capitali accumulati illegalmente possano essere riutilizzati. In questo modo il denaro accumulato illegalmente può essere avviato verso una qualsiasi attività economica, verso investimenti sia nel settore legale che in quello illegale; e se viene di nuovo immesso nell’economia illegale produrrà nuova liquidità che necessita di ripulitura: il ciclo del riciclaggio è così avviato.
Si possono distinguere tre momenti del ciclo criminale: l’accumulazione, il riciclaggio, il reinvestimento. Se il primo è sicuramente illegale, il secondo e il terzo possono essere legali. Il primo si muove dentro i divieti della legge, il secondo e il terzo sfruttando le leggi esistenti in materia. Se l’accumulazione è illegale, il riciclaggio e il reinvestimento avvengono dentro le regole e le leggi che regolano i mercati bancari e finanziari. Se l’accumulazione criminale si fermasse alla soglia del confine tra legale e illegale, il peso della criminalità sarebbe meno forte e preoccupante. In base al “veicolo” scelto si può identificare un riciclaggio monetario, un riciclaggio bancario e un riciclaggio finanziario, cioè un riciclaggio che si realizza attraverso la moneta, la banca o i circuiti finanziari. Queste tre forme rappresentano non solo tre fasi storiche delle particolari tecniche messe in atto per sfuggire ai controlli, alla repressione, al riconoscimento individuale, ma tre tecniche che si possono intrecciare a seconda delle necessità, per rendere impossibile alle autorità di sicurezza l’azione di prevenzione e di contrasto.
Nel caso della moneta, è indispensabile usare le banconote a maggiore valore. La carta moneta di 500 euro è quella preferita dai criminali, poiché un taglio così grande consente di trasferire grosse somme di danaro in una sola valigetta. Infatti le banconote da 500 euro sono molto utilizzate fuori dall’Europa, e in Italia (fino a poco tempo fa) a Forlì e a Como, cioè nei pressi di San Marino e della Svizzera, luoghi di deposito del denaro contante. E d’altra parte per i mafiosi la moneta cartacea ha un valore aggiunto, poiché la quasi totalità dei loro traffici illegali possono essere pagati solo in moneta circolante (droga, lotto clandestino, eccetera) e la banconota è l’unica che davvero può garantire l’anonimato. Non è mai capitato che si potesse pagare cocaina con bancomat e carte di credito!
Ciò non significa che le mafie non utilizzino anche la moneta virtuale (bitcoin) o che quest’ultima sia estranea a forme di riciclaggio a sua volta, anzi. Di certo, soprattutto nel caso del danaro cartaceo, un ruolo importante nel riciclaggio è svolto da banche o da impiegati compiacenti che, pur di fare cassa, non guardano in faccia al cliente, preferendo “tollerare il fango delle infiltrazioni criminali, piuttosto che introdurre granelli di sabbia nei movimenti di capitali”, come ha scritto Domenico Masciandaro.
E d’altra parte, occorre sottolinearlo, spesso il riciclaggio è un reato strettamente connesso ad altri reati economici come frode e corruzione. L’obiettivo di riciclare, infatti, può essere perseguito anche grazie alla corruzione di impiegati di banca o alla falsificazione di fatture. Se si permette di riciclare tanto denaro, vuol dire che più di qualcosa non funziona nel sistema di controllo e soprattutto nel sistema bancario di controllo. Per lavare il danaro bisogna rivolgersi al sistema bancario che perciò è fino in fondo dentro a questa problematica, risultando responsabile di una “ricorrente distrazione” se non di vera “complicità”.
Il riciclaggio può essere un reato scopo (fine a se stesso) o un reato mezzo (utile al perseguimento di altri reati) ma in ogni caso, come gli altri reati economici, abbisogna di specialisti. Tali attività illecite non si improvvisano, richiedono la collaborazione attiva di professionisti del ramo e una vera e propria organizzazione.
ima le mafie si rivolgevano, tra i professionisti, solo agli avvocati, perché ne assumessero la difesa nel corso dei processi a loro carico, oggi i mafiosi sono clienti abituali di altri professionisti che di solito contattano per ottenere consigli su come approfittare delle leggi in materia economica piuttosto che aggirarle. E, attorno all’interpretazione della legge, si sono costruite professioni legali, con specialisti dell’opacità. Sono questi gli “apriporta”, i “traghettatori” verso il grande mondo della finanza clandestina o meno.
Davanti a tali personaggi si incontrano mafiosi e imprenditori “normali” tutti animati dallo stesso scopo: fare profitti a molti zeri senza essere scoperti. Lo stesso professionista in maniera asettica serve entrambi i settori, quello dei ricchi e quello dei mafiosi, in maniera impeccabile. Essi, dunque, non scelgono i loro clienti ma sono scelti da loro e a loro offrono servizi, danno consigli.
Qualche esempio. Le nuove frontiere del gioco online e in particolare le scommesse sportive via internet hanno favorito il passaggio all’estero di grandi quantità di danaro delle mafie (e non solo!) in maniera assolutamente legale: basta una scommessa per lavare i propri soldi in modo riservato e dentro le regole. Sale bingo e sale da gioco diventano così vere e proprie lavanderie legalizzate.
Le nuove frontiere del gioco online e in particolare le scommesse sportive via internet hanno favorito il passaggio all’estero di grandi quantità di danaro delle mafie (e non solo!)
Si consideri il caso dell’evasione fiscale. Essa non si riduce all’evasione delle tasse di un piccolo esercizio commerciale, ma a una evasione ben più cospicua di intere aziende con guadagni significativi, spesso registrate in altri Paesi. E proprio l’evasione è un punto di incontro solido tra criminali e non, una di quelle cose che molti fanno per scopi diversi e per cifre diverse. Ma il reato è lo stesso. Perché “mondi diversi hanno la medesima esigenza: i mafiosi di nascondere i patrimoni, gli imprenditori di evadere, di occultare i guadagni in nero. Entrambi hanno un obiettivo analogo: celare le risorse”. Entrambi si affidano, ancora una volta, agli stessi meccanismi e agli stessi uomini, i professionisti delle magie finanziarie, a cavallo tra il legale e l’illegale, a-morali specialisti senza padroni e senza limiti, aiutati dagli strumenti moderni. Si pensi, infatti, al ruolo di primo piano che oggi ha internet nelle transazioni economiche. In pochi minuti con un solo clic è possibile trasferire conti bancari da un Paese all’altro. E a fronte di tutto ciò le leggi sembrano troppo confinate nei loro spazi, la giustizia appare troppo farraginosa e l’intero sistema di controllo risulta elefantiaco e datato. Globalizzazione e assenza di confini significano spesso economia libera ma strutturalmente “esposta”.
Le mafie, dunque, entrano nell’economia legale avendo il terreno già spianato da chi fa parte di un sistema di mercato “deviato” e lo fanno senza troppa difficoltà, perché non c’è un limite evidente, un confine preciso e visibile tra economia illegale e legale; non c’è una “marca”, una “patente”, una “etichetta” che distingue l’una dall’altra. È la legge che limita e contiene le spinte anarchiche del mercato che altrimenti ingloberebbe senza difficoltà tutto ciò che è vendibile, tutto ciò che è richiesto, tutto ciò che è monetizzabile. Ma il diritto come si è detto già non ha abbastanza forze per arginare il fiume in piena del mercato che già prima delle mafie ha ampiamente accolto capitali che derivano da violazioni delle leggi. È proprio questo sistematico accoglimento di capitali illegali una delle cause principali dell’accoglimento di capitali mafiosi.
Sono questi i nuovi canali di legittimazione mafiosa. Quelli economici. Non vengono dall’interno del mondo criminale abituale né dal loro ambiente sociale tradizionale ma dall’universo economico globalizzato.