Consumo di suolo
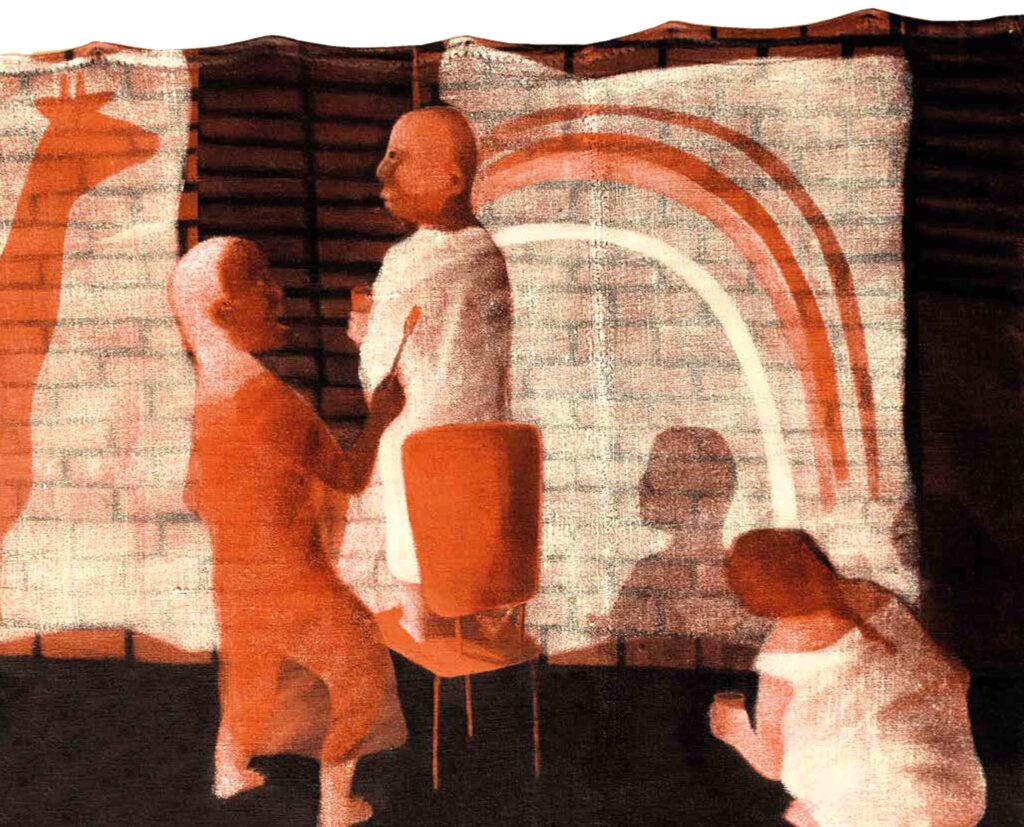
È da molti anni che il tema del consumo di suolo è entrato nel discorso politico urbanistico. Peccato che nel frattempo non si sia fatto nulla di realmente incisivo per arrestarlo, solo chiacchiere, molto fumo. Che si sono tradotte in diverse proposte di legge nazionali, tutte ferme al Parlamento, e negli incipit di leggi urbanistiche regionali che se da un canto ne fanno il puntello dichiarato di nuove filosofie di piano, dall’altro ne mortificano l’essenza nelle indicazioni applicative, con eccezioni di portata tale da contraddirne lo spirito. Molto giocando sull’ambiguità tra i termini “consumo zero” e “consumo netto”, dove il secondo sta a indicare uno scambio tra superfici liberate e superfici edificate la cui somma algebrica dovrebbe puntare allo zero, ma quando avviene spesso è tra suoli di qualità – ecologiche ed economiche – assai diverse.
Di recente qualcosa è cambiato, la quantità di suolo consumato si è abbassata, ma non per convinzione ambientale, bensì a causa della grande crisi globale e del repentino mutamento delle condizioni che l’hanno generata. La crisi infatti è stata conseguenza dell’esplosione della bolla che dalla fine degli anni novanta ha attribuito alle costruzioni un ruolo speculativo, si costruiva per investire e non in base alla domanda reale. Alla fine così si è costruito troppo. E come accade a ogni bene in esubero nelle tempeste dell’economia di mercato, le costruzioni, dopo valorizzazioni ingiustificate, sono precipitate in svalutazioni esiziali. Una rovina, sia per i proprietari indebitati con mutui, che per i costruttori, esposti con le banche in prestiti milionari. Una catena che si è condensata sugli istituti di credito ed è esplosa sui debiti insoluti, i famigerati “crediti deteriorati” o “insolvenze” che tuttora ci opprimono e sono aggravati dalla crisi pandemica, che hanno portato al crack del sistema finanziario e con ciò provocato il collasso dell’economia mondiale. Un percorso fatale puntellato sul consumo di suolo: 1,3 milioni di kmq, il 4,2% dell’intero territorio europeo, sono ricoperti da cemento e asfalto. L’Italia vince la classifica degli sprechi con il 7,1% di suolo consumato (Ispra, 2020), poco meno del doppio della media europea.
Ma perché dobbiamo contrastare il consumo di suolo? Il tema non riscuote l’attenzione che merita da parte dell’opinione pubblica, quella stessa che si mobilita contro inquinamento dell’aria e delle acque e contro surriscaldamento globale e cambiamento climatico. Mentre la Co2 e il calore incombente sono percepiti, patiti, il suolo, pur nella sua stringente matericità, rimane un’entità astratta, invisibile. Un sostrato amorfo e scontato, da calpestare e utilizzare, di cui non si coglie la valenza sistemica.
Eppure uno degli effetti immediati, più visibili e funesti dell’impermeabilizzazione dei suoli (soil sealing) è l’erosione causata dall’acqua che ne compromette le funzionalità e si traduce in dissesto idrogeologico e rovinose catastrofi. L’impermeabilizzazione incide sulla capacità di prevenire le inondazioni e la siccità, contrastare l’effetto serra e far fronte ai cambiamenti climatici. Il suolo svolge un ruolo fondamentale nel regime delle acque, può incamerare fino a 3.750 tonnellate di acqua per ettaro, o circa 400 mm di precipitazioni. Assorbimento che rallenta lo scorrere delle acque, ne riduce la portata e la capacità di dilavamento e perciò allontana il rischio di inondazioni, smottamenti, frane. Eventi che in Italia si susseguono con nefasta periodicità, ora aggravati dai mutamenti del regime climatico e dai fenomeni esasperati che lo accompagnano.
Nelle aree edificate le acque corrono sulle superfici impermeabili senza penetrare nel sottosuolo e si traducono in potenza distruttiva. Il mancato assorbimento ha un grave impatto anche sulla qualità e quantità di acque filtrate e incamerate nelle falde. Ciò complica l’approvvigionamento per usi civili, costringendo all’utilizzo delle acque di fiume, più lontane e di depurazione più complessa, onerosa e meno salutare. Nelle aree urbane il suolo determina inoltre il microclima: la riduzione della traspirazione e il maggior accumulo di energia solare delle superfici asfaltate o in cemento generano isole di calore, di conseguenza aumenta il bisogno energetico per raffrescamento.
L’occupazione di suolo limita la produzione di cibo, tanto più che si verifica in prevalenza nelle aree periurbane, che per atavica scelta allocativa sono spesso le più fertili. Sul pianeta le terre di altitudine e clima idonei a fini agricoli rappresentano una parte minima della superficie totale (le aree sfruttabili per la coltivazione in maniera naturale, senza necessità di impianti idrici o di drenaggio artificiali, sono solo l’11%) mentre la questione del cibo è tra le più rilevanti del nostro tempo.
Ma il suolo è innanzitutto primordio del vivente. Circa un quarto delle specie esistenti sul nostro pianeta, essenziali per la sopravvivenza delle specie di superficie, vive nei suoli. I microrganismi decompongono i materiali organici, riciclano i nutrienti e provvedono al sequestro e allo stoccaggio del carbonio. Insieme a organismi più grandi sviluppano la struttura del suolo rendendolo poroso e permeabile. È dunque un baluardo della biodiversità, sia del sottosuolo che di superficie.
Un documento dell’Unione europea del 2006 riassume con chiarezza le valenze molteplici del suolo:
“Per ‘suolo’ si intende lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi. Rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Il suolo ci fornisce cibo, biomassa e materie prime; funge da piattaforma per lo svolgimento delle attività umane; è un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono stoccate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l’acqua, i nutrienti e il carbonio”.
E precisa che
“per l’importanza che rivestono sotto il profilo socioeconomico e ambientale, tutte queste funzioni devono pertanto essere tutelate. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile”
(Com, 2006/231).
Il termine “suolo” fa dunque riferimento a un complesso sistemico di elementi e di correlazioni che attiene più sfere semantiche, quella biochimica, quella antropologica, quella economica. È il presupposto fondativo dei processi di evoluzione umana, dall’agricoltura ai percorsi di trasformazione che hanno accompagnato nel tempo le diverse civiltà. Con profili culturali che hanno prodotto modelli organizzativi e paesaggi di estrema originalità, unicità. Che racchiudono la nostra storia e definiscono la nostra identità, collettiva e finanche personale, psicologica. Patrimoni materiali e simbolici che il consumo sconsiderato di suolo ha profondamente lacerato, offeso, deturpato, cancellato, che vanno difesi e salvaguardati come principio di vita, memoria e allo stesso tempo futuro delle generazioni e delle genti.
Questo articolo è disponibile gratuitamente grazie al sostegno dei nostri abbonati e delle nostre abbonate. Per sostenere il nostro progetto editoriale e renderlo ancora più grande, abbonati agli Asini.