Catalogo di accuse comuni a uno scrittore
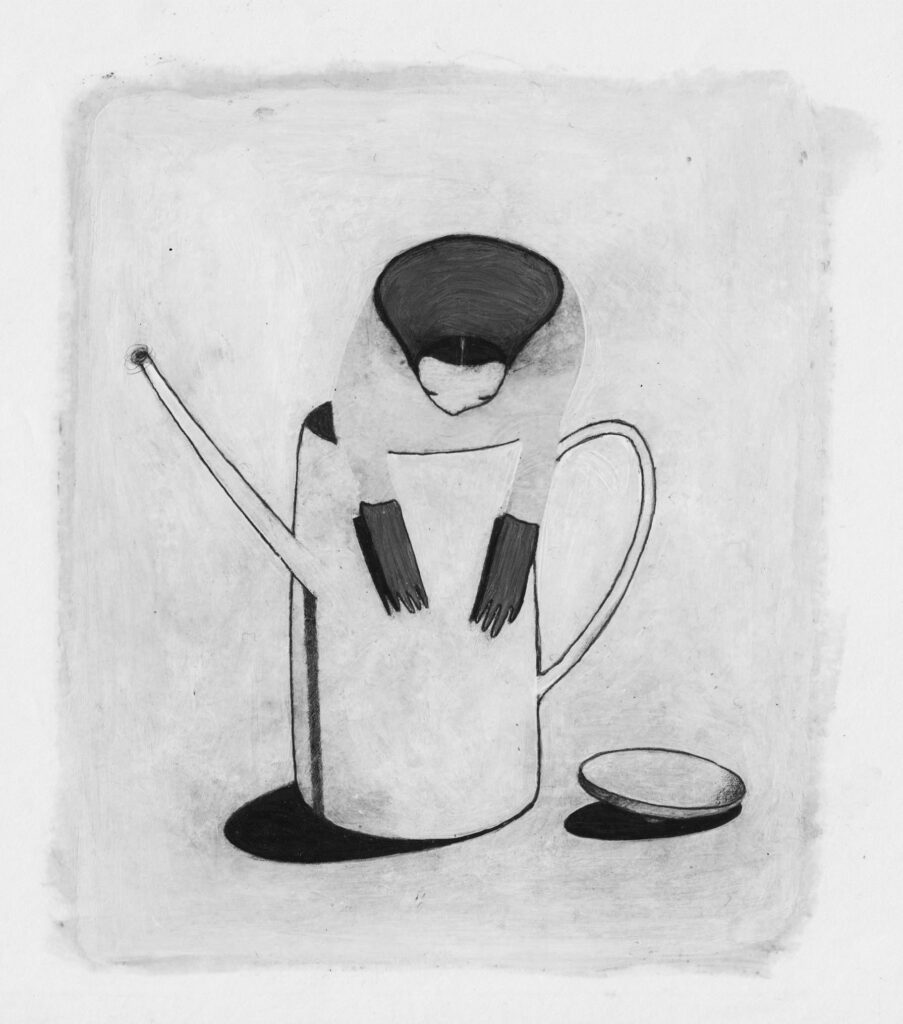
disegno di Roberto Catani
4 Aprile 2022
Si diventa scrittori per genio o per amore della lettura. La seconda categoria forse dovrebbe lasciare perdere ma l’amore non corrisposto è, a sua volta, un grande classico della letteratura e quindi non ho lasciato perdere. Alcuni decenni dopo non so se sono uno scrittore, probabilmente no. Ma mi mantengo con la scrittura e sono […]